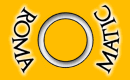Lunedì 12 Aprile 2021 08:04
L’Omino in metrò – L’ultimo dono: Katerina
Mattia era in piedi nella stazione Subaugusta in attesa dell’arrivo del treno. Il display lo dava in ritardo di 15
… Continua...
leggi la notizia su Cultura - ABITARE A ROMA
Mattia era in piedi nella stazione Subaugusta in attesa dell’arrivo del treno. Il display lo dava in ritardo di 15 minuti. Ogni tanto si muoveva, facendo qualche passo su e giù per ingannare il tempo, tenendo la mano sinistra ben al caldo nella tasca del cappotto mentre con l’altra teneva la valigetta. Quella mattina si stava recando al lavoro come al solito ma con la testa era come fosse altrove. Era preso dai suoi pensieri. La gente gli passava vicino ma lui non se ne avvedeva. Guardava fisso in terra e i suoi occhi erano un po’ mesti. Non lacrimavano ma ci mancava poco.
Percepiva un lieve pizzicore agli occhi che gli erano diventati umidi ma non era per il freddo. Una reazione che partiva da un ricordo. Un ricordo doloroso che stava rivivendo in quel preciso momento.

Sui televisori della stazione aveva appena visto le immagini dell’anno scorso quando i camion dell’esercito trasportavano le bare delle prime vittime del covid19. Si muovevano in colonna, lentamente, sotto gli sguardi delle persone affacciate alle finestre delle case che accennavano timide riprese con la telecamera dei cellulari. Increduli e attoniti osservavano quell’incedere lento, un modo per omaggiarli, per offrire loro un ultimo saluto.
Erano morti contagiati per una colpa non loro. Nella malattia erano stati trattati con timore e una volta deceduti considerati quasi degli appestati. Non potevano essere toccati. Avvolti in sacchi neri della spazzatura non erano stati nemmeno adeguatamente vestiti per l’ultimo viaggio. Nessun saluto da parte dei parenti neppure quelli più stretti. Nessuna cerimonia funebre. Un dolore nel dolore, in un silenzio surreale accompagnato a volte da un cielo azzurro limpido, senza vento.
Nei cimiteri iniziavano a non trovarsi più posti e, per limitare il contagio, si preferiva la cremazione. Le ceneri venivano consegnate ai parenti ma in loro covava l’atroce dubbio di non ricevere quelle del proprio caro, poiché forse mischiate con quelle di altri feretri. Una tragedia nella tragedia che nemmeno un urlo straziante liberatorio potrà mai cancellare.
Mattia era molto triste. Quelle scene gli ricordavano sua madre, purtroppo anche lei deceduta in quel periodo e in quei frangenti. Una ferita ancora aperta.
Sul video nella stazione scorrevano le immagini del TG. A Bergamo una cerimonia solenne in presenza del sindaco e del presidente Mario Draghi commemorava quelle vittime morte in solitudine confortate solo da gentili parole di qualche estraneo infermiere meritevole del nostro più sincero ringraziamento. A distanza di un anno il servizio sanitario nazionale è stato candidato al premio Nobel e il governo ha designato il 18 marzo come il giorno del ricordo delle vittime del contagio del covid19.

Il treno giunse stridendo sulle rotaie. Il conducente era sopraggiunto troppo in velocità e la frenata repentina aveva causato uno sballottamento dei passeggeri fortunatamente senza provocare nulla di grave: alcuni si erano tenuti saldamente ai loro posti mentre altri, anche se sbilanciati, erano riusciti a mantenersi comunque in piedi, senza cadere. Si aprirono le porte e alcuni scesero, ancora un po’ straniti per quell’imprevisto. Mattia a quel rumore si destò e salì in carrozza. Non riuscì però a trovare un posto a sedere e allora rimase in piedi aggrappandosi alla maniglia della spalliera di un sedile con la faccia rivolta al finestrino. Si chiusero le porte e la metro proseguì. Mentre il treno man mano accelerava, poteva scorgere la sua sagoma riflessa sul vetro, al di là del quale ora c’era solo il buio, nero e gelido come nello spazio dell’Universo nel quale lui in quel momento era immerso, solo. Nel riflesso però non si specchiava il suo volto poiché le luci erano poste in alto e al centro del vagone. Meglio così, altrimenti avrebbe visto una piccola lacrima colargli sulla guancia. Non la vedeva però la percepiva. Fredda e tagliente nel suo piccolo percorso.
Il treno nel frattempo aveva intrapreso la sua marcia in modo sostenuto e veloce e ciò lo fece leggermente sobbalzare e quella lacrima scivolò giù, sulla punta della sua scarpa. Silenziosamente si infranse sul tessuto di camoscio della sua clarke e ne fu assorbita attutendo il rumore di quel dolore che era solo suo. Non voleva che il treno lo condividesse con lui nonostante quei continui sobbalzi sembrassero volerlo cullare in una sorta di abbraccio materno, come se la metro fosse un’entità vivente.
Nel suo ventre poteva quasi percepire ogni umore di chi vi viaggiava e, a suo modo tentava di aiutarlo come uno psicologo fa con il proprio paziente, o ancora meglio di coccolarlo come una mamma fa col suo bambino. Mattia non distolse mai lo sguardo e rimase immobile a fissare il finestrino. Il buio della galleria che si intravvedeva al di là del vetro, era interrotto raramente solo da qualche luce posta sul percorso, ed insieme alla velocità del treno, si produceva in lui uno strano effetto, come se gli scorressero davanti agli occhi i fotogrammi della pellicola di un film, ma quel film era già stato girato ed era purtroppo tutto memorizzato nella sua mente.
Il 2 febbraio 2020 verso le 17.00 l’aveva trovata seduta per terra nel corridoio e l’aveva soccorso. Suo padre piangeva disperato. Provò a tirarla su cingendole i fianchi ma si accorse che il femore si era rotto e il piede era ripiegato verso l’interno. Lei tuttavia era lucida ma non comprese la gravità della sua condizione. Non lamentava alcun dolore. Non la spostò e cercò di tranquillizzarla. Venne il 118 e la portarono all’ospedale San Giovanni. Egli avvisò sua sorella che lo raggiunse al pronto soccorso. L’attesa fu lunga e straziante. La hall era molto affollata e l’arrivo delle ambulanze era continuo. Sul grande display al centro della parete scorrevano i codici di emergenza definiti dai colori dal bianco al rosso. In quel caos non era facile avere notizie e l’ansia di averle saliva. Ogni tanto entrava un’infermiera per chiamare parenti dei pazienti ricoverati presenti in sala. Alla fine toccò anche a loro ma solo a uno era consentito salire. Andò Mattia. Il medico era seduto davanti ad un computer intento ad inserire i dati delle diagnosi dei pazienti. Era nervoso poiché l’applicazione si era bloccata. Si alzò dalla sedia e andò incontro a Mattia, che era rimasto in piedi trepidante sulla soglia della porta. Gli parlò con schiettezza: le probabilità di guarigione in considerazione dell’età della paziente erano poche, solo il 40%.
Mattia non diede troppo peso a quelle parole. Non si rendeva ancora conto della gravità. Era speranzoso. A mezzanotte inoltrata gli permisero di salire al quarto piano. Trovò sua madre nel letto nel reparto di neurochirurgia perché in quello di ortopedia non c’era posto. Era sveglia. Seduta con lo schienale quasi del tutto tirato su. Era tranquilla. Non aveva paura. Gli parlava ma non disse nulla di sensato. Mischiava il passato col presente. Lui la guardava e annuiva. Si era fatto tardi, un’infermiera si affacciò esortando in modo pacato e gentile che occorreva uscire. Mattia si alzò dal letto su cui si era seduto, accarezzò dolcemente e baciò sua madre sulla fronte. Fu solo allora che notò la vicina di letto.
Era Katerina, una ragazza russa di ventidue anni. Concentrato su sua madre non se ne era accorto della sua presenza. Anche a causa delle luci soffuse nella penombra della stanza non si notava. Era ancora sveglia e in silenzio ascoltava musica con gli auricolari collegati al cellulare. Era idrocefala ed era lì per fare l’operazione definitiva che consisteva nel trapiantare un tubicino dalla testa fino all’addome. Adesso era esterno il tubicino. Glielo mettevano solo quando ne aveva bisogno. Per anni era stato così. Aveva i capelli tagliati a zero e sopra alla testa, dalla parte sinistra, si notava un cerotto bianco a forma di croce. Le sue ciglia erano lunghissime e aveva dei bellissimi occhi azzurri. Luccicavano quegli occhi. Per come splendevano sembrava emanassero una luce come quella dei santi. Era bella Katerina. Soprattutto era bella dentro. Aveva un sorriso buono e dalla sua sofferenza aveva imparato molto.
Lei era consapevole di cosa volesse dire stare male, essere diversi e avere bisogno di una parola di conforto. E così fece anche con Mattia. Vedendolo preoccupato per la madre le diede il suo telefono per potergli inviare dei whats-app e tenerlo informato sul suo stato di salute. Non si era reso conto subito della grave condizione di Katerina. Quando lo seppe si vergognò di se stesso per la sua assenza di sensibilità: era giustamente preoccupato per la madre novantenne ma non aveva considerato che davanti a sé aveva una giovane ragazza fragile la cui vita era appesa ad un filo. E addirittura era lei a confortarlo. Era davvero dolce Katerina.
Fu di parola. La mattina dopo al suo risveglio gli inviò la foto della madre informandolo di cosa avesse mangiato per colazione. Mattia era più sereno ora.
La situazione però non era così tranquilla. Il quadro clinico di sua madre era quello di un soggetto anziano e molto labile. Nel frattempo il virus incominciava a far parlare di sé nei telegiornali. Due turisti cinesi erano stati ricoverati a Roma allo Spallanzani dopo che si erano sentiti male, accusando sintomi febbrili. Il virus era arrivato in Italia. Poi un altro caso al Nord, il primo italiano. In poco tempo varie zone della Lombardia furono coinvolte dal virus. Senza difesa. Senza un allarme specifico. Eppure in Cina già era presente da mesi ma l’Europa stranamente non si era allertata ed attrezzata ad una eventuale Pandemia.
Il giorno dopo Mattia tornò a trovare la madre. Entrando nella stanza vide Katerina circondata dai due fratellini più piccoli. Avevano sette e nove anni. Seduta sul letto giocava con loro canticchiando delle canzoncine e battendo reciprocamente con loro le mani. Sua madre dormiva e lui aveva quasi paura a svegliarla. Katerina le disse che era stata sveglia tutto il tempo e che addirittura aveva cantato. Sì, lei era solita cantare specialmente quando si annoiava. Disse che si era addormentata da poco. Guardò Katerina e nonostante avesse la testa rasata non gli faceva impressione. Aveva un sorriso il quale emanava quella luce particolare. Mentre giocava spensierata con i fratellini esprimeva una gioia di vivere da fugare qualsiasi brutto pensiero. Era positiva pur nella sua sofferenza. Lui ne era affascinato. Le suscitava una energia che, a sua volta, alimentava un sentimento di ottimismo e che poi si trasformava in speranza. Un vero mistero di fluidi invisibili che s’infondono sulla nostra anima in grado poi di realizzare i nostri sogni.
Nel frattempo la madre si era svegliata. Mattia la guardava con occhi diversi ora. Era pronto a qualsiasi destino. Lui l’avrebbe accettato.
Dopo due giorni fu trasferita nel reparto ortopedico giù al secondo piano. In quei giorni ebbe un andamento altalenante e le dovettero fare delle trasfusioni. Al sesto giorno fu operata. Le applicarono un ferro nel femore. A detta dei medici l’operazione era riuscita bene. Di fatto non fece mai terapie. Tentarono di farle fare ginnastica ma dissero che era poco collaborativa.
Mattia intanto non si era dimenticato di Katerina. Un giorno salì al quarto piano per andarla a trovare ma non c’era più. Era stata operata e dimessa. Parlò con una infermiera e le disse che l’operazione era riuscita. Era dispiaciuto di non averla potuta salutare ma lo fece tramite whats-app. Era felice per lei.
Sul suo diario segreto scriveva ogni sera tranne nei giorni che era proprio stanco. E a lei scrisse una dedica: “A Katerina”
Katerina è la vita. Quella vera. Quella che dovrebbe essere. Quella che non si vede nei telegiornali, nella cronaca quotidiana, perché le storie positive, quelle belle, interessano a pochi e non fanno audience. Invece, Lei è l’espressione della vita quella bella che pensiamo non esista, quella senza sentimenti negativi e senza apparente malessere. Ma invece Katerina il malessere ce l’ha. Ha la testa rasata e ferita con sopra i cerotti che le coprono i tagli del chirurgo. Non si vedono ma si possono immaginare. Lei non lo fa pesare perché è pura dentro. Sorride al mondo con i suoi occhi azzurri lucenti, raggianti di gioia, e seppure così malconcia, Katerina è bella.
Mattia andava tutti i giorni a visitare sua madre, con il padre e la sorella. Si aggregava molto spesso anche la zia che, nonostante i suoi ottant’anni, sprigionava simpatia in tutto il reparto. Imboccavano sua madre come una bimba. A volte lei parlava, altre volte no. Ma con lo sguardo si faceva capire.
Giulia, l’infermiera del reparto ortopedico era gentile. Si prese a cuore la madre di Mattia, ma come qualsiasi altro paziente bisognoso di assistenza. Il lavoro dell’infermiere non è facile. Lo devi svolgere con passione altrimenti non ce la fai e i pazienti se ne accorgono. Il lavoro per Giulia era come una missione. Eppure aveva i suoi problemi. Si era separata da poco col compagno e viveva in affitto sola con la figlia, una ragazza madre di una splendida bimba dai capelli biondi. Eppure trovava la forza di sorridere. Tranquillizzava Mattia, lo rassicurava. Specialmente nei momenti difficili, quando la madre aveva dei cali fisici e stesa sul letto sembrava non farcela. Faceva impressione. Mattia la guardava impotente e a volte non ce la faceva a trattenere la commozione. Allora usciva nel corridoio con la scusa di lavarsi le mani con un po’ di gel per non mostrare a suo padre gli occhi lucidi.
I giorni passarono con la solita routine. Mattia non si perse una visita serale. Con la sorella si alternavano con i turni del pranzo e della cena. Il virus però incominciava a dilagare. I casi aumentavano e nell’ospedale questo si avvertiva. Avevano imposto l’uso di mascherine e gli infermieri stessi le fornivano ai parenti che venivano a far visita ai malati. Facevano entrare solo una persona per paziente. Mattia imboccava sua madre tirandola su, sollevando lo schienale del letto. Lei lo guardava ma non parlava.
Era trascorso ormai quasi un mese e occorreva lasciare il posto. Fu assegnata ad una clinica di Nemi nei Castelli Romani.
La struttura era posta in alto e dal piazzale antistante si vedeva il piccolo lago vulcanico circondato dall’antico cratere. Era contento Mattia. Un po’ lontano da casa ma la vista di quel panorama lo rasserenava e faceva sperare che le cose potessero mettersi bene.
Sua madre era entrata lì il 29 febbraio. Dopo una settimana Mattia non l’avrebbe più vista. L’8 marzo chiusero al pubblico la clinica. Un DPCM del presidente del consiglio Antonio Conte precluse la possibilità di far visita ai propri cari. Mattia sentì la sua voce solo per telefono grazie a qualche infermiere che l’aiutava ad avvicinare all’orecchio un altro telefonino che lo stesso Mattia le aveva lasciato. Non era facile nemmeno parlare col medico. Si seppe solo dopo che nella clinica c’erano casi covid e i medici non avevano tempo per rispondere al telefono. Voleva portarla via Mattia ma non fece in tempo.
E così nel giorno di Pasqua sua madre volò in cielo.

Era quasi arrivato ad Ottaviano. Non se ne sarebbe nemmeno reso conto se non avesse sentito un signore chiedere informazioni ad un altro passeggero sulla fermata per andare alla Basilica di San Pietro. Allora Mattia si avvicinò all’uscita del vagone. Si aprirono le porte e uscì. Il suo passo era lento. Non aveva fretta e quel giorno non gli importava di fare tardi al lavoro. Superò il tornello, salì i gradini dell’uscita e si ritrovò su via Ottaviano. Fu colpito in volto da una fresca brezza mattutina. Era una bella giornata piena di sole. Superò i soliti falsi poveri elemosinanti che da anni occupavano quei marciapiedi e arrivò a piazza Risorgimento. Il 19, un tram che faceva capolinea nella piazza, a momenti stava per investirlo distratto com’era. Camminò per via di porta Angelica davanti alle guardie svizzere. Passò sotto il portico del colonnato ed infine si trovò nella maestosa piazza di San Pietro. Quando fu al centro si girò verso la facciata della Basilica lasciandosi dietro le spalle l’obelisco egizio, pose in terra la valigetta, si fece il segno della croce e congiunse le mani per fare una preghiera. Guardò in alto la croce dorata del cupolone che in quel momento era sovrastato da un cielo dalle colorate sfumature gialle e rosse provocate da un sole mattutino che quel giorno faceva fatica a sorgere. Col pensiero recitò un “eterno riposo”, salutò, rivolto al cielo, la madre e poi rifece il segno della croce. Si mise la mano sulla bocca e indirizzò un bacio verso la Croce come per farlo volare via. Riprese la valigetta e proseguì guadagnando l’uscita verso Porta Cavalleggeri.

Sua madre era andata via e lui non era più lo stesso. Quello che prima non era e che voleva essere, ora era. Come fosse nato una seconda volta. Ogni esperienza di vita dona qualcosa ma il dono va afferrato. Occorre aprire il nostro animo per poter captare ciò che c’è ma che non vediamo. Lo vediamo solo se il nostro animo si predispone a recepirlo. Grazie alla madre aveva conosciuto Katerina ed era stata lei la chiave. Bastò averci parlato anche solo per poco tempo per aprire il suo animo ed ora a distanza di tempo lo aveva capito. Come si fosse svegliato da un lungo sonno in cui si era assopito. “L’ultimo dono” ricevuto da lei oltre al primo: quello della vita. Ed ora poteva camminare più sicuro di sé, senza paure di affrontare il mondo e le sue ingiustizie. E questo anche il treno della metro lo sapeva.