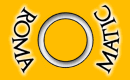Mercoledì 23 Ottobre 2024 23:10
Metro C: la “baricentrica” per l’ansa barocca

Come realizzare la stazione Navona, alternativa a Chiesa Nuova di Paolo Arsena e Corrado Cotignano Abbiamo riscontrato con piacere un apprezzamento fattivo all’articolo che pubblicammo con Roma Ricerca Roma all’inizio del 2023: “Metro C: proposte per un progetto compiuto”. Da allora l’amministrazione ha steso il progetto definitivo della tratta T2, oggi in fase di […]
L'articolo
Metro C: la “baricentrica” per l’ansa barocca
proviene da La Metrovia
.leggi la notizia su La Metrovia

Abbiamo riscontrato con piacere un apprezzamento fattivo all’articolo che pubblicammo con Roma Ricerca Roma all’inizio del 2023:
“Metro C: proposte per un progetto compiuto”
. Da allora l’amministrazione ha steso il progetto definitivo della tratta T2, oggi in fase di approvazione e validazione, ma ha anche riaperto il dibattito e le riflessioni relativamente alla fermata dell’ansa barocca “Chiesa Nuova”, oggetto delle nostre osservazioni.Di più. A fine maggio 2024 il Consiglio Comunale, su proposta dell’onorevole Francesco Carpano, ha
approvato la mozione
che ha vincolato la giunta a impegnare gli uffici del dipartimento mobilità per studiare una soluzione alternativa. Compresa quella “a due pozzi” da noi rilanciata.Alla luce di questi sviluppi, riteniamo dunque utile tornare sui temi sollevati. E lo facciamo anzitutto con questo primo articolo di approfondimento, anche tecnico, su quella che riteniamo la migliore soluzione possibile per l’ansa barocca.

Avevamo già evidenziato l’inadeguatezza della fermata Chiesa Nuova, per i seguenti motivi:
- non è baricentrica tra Venezia e Sant’Angelo, ma troppo sbilanciata su quest’ultima, come da schema dei “raggi di captazione” delle fermate, che evidenzia una corposa sovrapposizione e una significativa porzione che rimane scoperta (Fig. 01);
- non coglie i principali attrattori della zona, come largo di Torre Argentina, il Pantheon, piazza Navona, Campo de’ Fiori (Fig. 02);
- impatta sul tracciato del tram TVA e quindi sul regolare ed efficace funzionamento della futura tranvia, per tutta la durata dei lavori, cioè per svariati anni (Fig. 03).



Aspetto quest’ultimo da non sottovalutare, perché quel tram, se attivo quando cominceranno i cantieri, svolgerà un ruolo suppletivo essenziale per i collegamenti e l’attraversamento del centro storico. E dovrà farlo in piena funzionalità, senza intralci o rallentamenti, se vogliamo che le nuove opere di mobilità segnino presto una reale discontinuità nella percezione del servizio di trasporto pubblico.
Se invece il TVA non sarà ancora attivo, la presenza del cantiere di Metro C comporterà uno slittamento del progetto sine die, e di fatto il rischio che quel tram possa non vedere mai la luce.
Se invece il TVA non sarà ancora attivo, la presenza del cantiere di Metro C comporterà uno slittamento del progetto sine die, e di fatto il rischio che quel tram possa non vedere mai la luce.
Rispetto alla prima esigenza, avevamo evidenziato come il tema della copertura del servizio e degli attrattori avesse due soluzioni possibili:
- passare al modello “a quattro stazioni”, aggiungendo a Chiesa Nuova la fermata Argentina;
- spostare Chiesa Nuova in posizione più baricentrica (la proposta rilanciava l’opzione della fermata Navona “a doppio pozzo”, uno in piazza Sant’Andrea della Valle, l’altro a San Pantaleo).
Nel primo caso, lungo il segmento che congiunge piazza Venezia con Castel Sant’Angelo e San Pietro, otterremmo appunto quattro stazioni invece che tre.
Questa soluzione è decisamente coprente (Fig. 04), seppure con molte sovrapposizioni nei bacini d’utenza (e quindi con una certa ridondanza). Ma non risolve il tema della compatibilità col tram, bensì lo aggrava.
Questa soluzione è decisamente coprente (Fig. 04), seppure con molte sovrapposizioni nei bacini d’utenza (e quindi con una certa ridondanza). Ma non risolve il tema della compatibilità col tram, bensì lo aggrava.

Vengono infatti mantenute tutte le criticità legate alla convivenza del TVA con l’area di cantiere di Chiesa Nuova (probabili deviazioni in promiscuo col traffico auto, tratto a binario singolo, attese semaforiche per gestire i passaggi etc.) e vi si aggiungono quelli del cantiere Argentina, anch’esso posizionato sulla direttrice del tram.
Argentina offre maggiori occasioni per garantire al TVA un servizio quasi normale, considerando la possibilità di deviare il suo percorso su via delle Botteghe Oscure invece che passare per via del Plebiscito. Ma questo espediente non è indolore: il Sedime tranviario, come la sede carrabile, dovrà adattarsi a tutte le fasi di cantiere della stazione Venezia, con una periodica variazione del breve tracciato di piazza Venezia su binari provvisori, da percorrere a velocità molto bassa.
Fattori sopportabili se limitati soltanto a questo; aggravanti se agiscono in concomitanza con i disagi che il cantiere di Chiesa Nuova apporterà al servizio. È dunque chiaro che con questa opzione l’obiettivo di mantenere sin da subito un tram in piena efficienza, per tutta la durata dei cantieri, verrebbe assolutamente vanificato.
Fattori sopportabili se limitati soltanto a questo; aggravanti se agiscono in concomitanza con i disagi che il cantiere di Chiesa Nuova apporterà al servizio. È dunque chiaro che con questa opzione l’obiettivo di mantenere sin da subito un tram in piena efficienza, per tutta la durata dei cantieri, verrebbe assolutamente vanificato.
Infine il modello a quattro stazioni è anche il più dispendioso, perché si tratterebbe di aggiungere una fermata al modello previsto dal progetto definitivo.
Come già evidenziato nel documento precedente, la soluzione ideale, capace di rispondere a tutte le esigenze, è quella di sostituire la fermata “Chiesa Nuova” con la fermata “Navona”, più centrata tra Sant’Angelo e Venezia e a copertura piena di tutte le principali destinazioni della zona.
E a questo proposito avevamo rilanciato una vecchia proposta del comitato MetroXRoma: la stazione “a due pozzi”, con batterie di ascensori per la risalita nelle piazze San Pantaleo e Sant’Andrea della Valle.
E a questo proposito avevamo rilanciato una vecchia proposta del comitato MetroXRoma: la stazione “a due pozzi”, con batterie di ascensori per la risalita nelle piazze San Pantaleo e Sant’Andrea della Valle.

Il problema finora emerso dalla fase di studio è quello costruttivo: tale sistema (Fig. 05) è considerato rischioso per possibili cedimenti. Trattandosi di un unicum in una zona così delicata (le banchine sarebbero realizzate “in allargo”, in profondità, ma sotto il pregevole Palazzo Massimo alle Colonne), la Soprintendenza ritiene che non vi siano riscontri di una corrispondenza effettiva tra le deformazioni reali e quelle teoriche calcolate, per cui prudenza vuole che non si mettano a rischio monumenti di tale valore.
“Navona” però continua ad essere la soluzione ideale. A rafforzare questa opzione rispetto a “Chiesa Nuova” è anche un primo sguardo al bacino d’utenza, che analisi più specifiche potranno certamente avvalorare. Da un conteggio degli abitanti della zona sulla base del censimento ISTAT, emerge una sostanziale parità sui residenti a meno di 500 mt. dalle stazioni, cui andranno aggiunti gli addetti. A sbilanciare decisamente a favore di Navona è però il flusso dei turisti, concentrato sicuramente qui, dove il numero dei monumenti e delle attrazioni è di gran lunga superiore.
Dunque, consci che il miglior risultato costi-benefici stia in questa soluzione baricentrica, desideriamo indicare una nuova proposta costruttiva, che ci pare ottimale a soluzione di ogni problema: utilizzare, oltre alla piazza di S. Andrea della Valle, anche le due piazzette ai lati della chiesa (Fig. 06).

La nostra nuova proposta, quindi consiste in una stazione così articolata (Fig. 07):
- un solo pozzo situato in piazza Sant’Andrea della Valle (rinunciando quindi al secondo pozzo di piazza San Pantaleo), con batterie di ascensori veloci e scale di emergenza elicoidali lungo le pareti;
- uno o due scatolari di stazione contenenti altre batterie di ascensori (o in subordine le tradizionali scale mobili), in Largo dei Chiavari e/o in piazza Vidoni. Una sola o entrambe, in base ai flussi attesi, sicuramente consistenti per una stazione così centrale.

N.B. I disegni e gli schemi che rappresentano la proposta definiscono gli ingombri massimi, all’interno dei quali è possibile definire le superfici e i volumi realmente necessari.
Nel caso di “Navona”, anzitutto occorrono due interventi che tutelino dal rischio di danneggiamenti del patrimonio esistente. Da un lato, per minimizzare le possibili subsidenze, si portano più in profondità i tunnel della metropolitana (le cosiddette “canne” costruite dalle talpe escavatrici), a circa 45-50 metri; dall’altro si divarica il loro tracciato, spostando la canna nord su una direttrice parallela adeguatamente distanziata, evitando così il passaggio sotto il patrimonio superficiale di maggior pregio (Fig. 08-09).


08-09– La soluzione di Navona con lo spostamento della canna nord e il suo schema volumetrico.
Il pozzo principale di stazione viene posizionato tra le due canne, in piazza Sant’Andrea della Valle, che è sufficientemente grande per scavare un diametro ottimale di circa 24 metri (c’è spazio per arrivare fino a 32 mt.), contenendo il cantiere entro il perimetro della piazza, senza sbordare sul rettifilo di Corso Vittorio Emanuele II.
Per le banchine, lo spostamento della canna nord rispetto al tracciato definitivo consente di sfruttare in massima parte punti privi di edifici per fare, in sotterranea, lo scavo in allargo.
Infatti la banchina nord passa sul largo del Teatro Valle e solo in parte cade sotto il palazzo INA che si affaccia sulla piazza (sorto nel 1937 con il corso Rinascimento che ha sventrato il tessuto storico). La banchina sud è invece scavata in allargo sotto corso Vittorio, dal momento che la rispettiva canna è mantenuta nello stesso tracciato oggi previsto (sia pure più in profondità).
Infatti la banchina nord passa sul largo del Teatro Valle e solo in parte cade sotto il palazzo INA che si affaccia sulla piazza (sorto nel 1937 con il corso Rinascimento che ha sventrato il tessuto storico). La banchina sud è invece scavata in allargo sotto corso Vittorio, dal momento che la rispettiva canna è mantenuta nello stesso tracciato oggi previsto (sia pure più in profondità).
Le banchine sono collegate al mezzanino del pozzo di stazione con gallerie scavate interamente in sotterranea, “a foro cieco”. Dal mezzanino si arriva in superficie con gli ascensori.
Lo schema è rappresentato in Fig. 10.

Per integrare la capienza degli spazi e diversificare la distribuzione degli accessi, possiamo associare al pozzo uno o due scatolari, utilizzando uno o entrambi gli spazi ai lati della Chiesa di Sant’Andrea della Valle: largo dei Chiavari a ovest e soprattutto piazza Vidoni a est, più ampia (schema di Fig. 11).
Questi scatolari contengono le discenderie per arrivare alla quota dell’atrio del pozzo, raggiungibile con gallerie di connessione (sezione di Fig. 12).
Il collegamento con l’esterno può avvenire con ulteriori batterie di ascensori, ma non è esclusa l’opzione delle scale mobili. In questo caso però occorre fare i conti coi tempi di risalita, decisamente più lunghi rispetto agli ascensori (e quindi assai meno incentivanti, a rischio di renderle sottoutilizzate).


Per il pozzo, il modello preso a riferimento e riadattato, è sempre quello della nuova stazione Capodichino della metropolitana 1 di Napoli, in costruzione dalla stessa Webuild di Metro C. Una fermata per una linea metro pesante, con affluenza paragonabile al caso nostro, trattandosi dell’aeroporto internazionale di Napoli (quarto scalo in Italia con 12 milioni di passeggeri nel 2023).
La fermata di Capodichino ha un corpo di stazione a pozzo con diametro di 36 mt., infossato per 48 mt., con un atrio profondo scavato in allargo, che collega le due canne della metropolitana. La risalita in superficie avviene solo con batterie di 8 ascensori e scale di emergenza elicoidali.


Si fa inoltre presente che la scelta tecnica dei pozzi di stazione è ampiamente prevista per la realizzazione delle fermate della futura Metro D di Roma, sia pure con le debite differenze dovute alla diversa quantità di flussi.
Riteniamo che l’utilizzo diffuso degli ascensori veloci, sul modello di quelli installati nei grandi grattacieli, accompagnato dalle rampe elicoidali dell’atrio ed eventualmente da scale aggiuntive di sicurezza negli scatolari, sia il mezzo ideale per soddisfare ogni esigenza, avendo il vantaggio della capienza e della rapidità.
Si possono immaginare batterie per complessivi 10-16 elevatori, distribuiti su uno, due o tre punti d’accesso, dimensionati per smaltire il carico di circa 1.200 persone ogni tre minuti.
Si possono immaginare batterie per complessivi 10-16 elevatori, distribuiti su uno, due o tre punti d’accesso, dimensionati per smaltire il carico di circa 1.200 persone ogni tre minuti.
Anche la metropolitana di Barcellona ha fatto uso di questo sistema per la linea L9 in sei stazioni ciascuna dotata di 6 ascensori veloci e 2 per disabili. A dimostrazione che l’innovazione delle batterie di ascensori sta cominciando a rimpiazzare il concept tradizionale delle scale mobili.


Con la soluzione individuata, i vantaggi sarebbero molteplici e vengono di seguito riassunti.
- La fermata è baricentrica tra Venezia e Sant’Angelo, ed è in grado di “scaricare” Venezia di parte dei flussi turistici, che altrimenti si concentrerebbero in quest’ultima per accedere alle tante attrazioni del centro storico.
- La posizione è perfetta per accedere a tutti i principali luoghi di interesse.
- Il cantiere non è invasivo per il percorso del TVA, che può effettuare normale servizio per tutta la durata dei lavori.
- Gli ascensori garantiscono rapidità di accesso e di risalita, rendendo più attraente l’uso del mezzo, anche per le persone anziane.
- Gli accessi su entrambi i lati di corso Vittorio consentono di distribuire meglio i flussi diretti alle attrazioni turistiche, piazza Navona e Pantheon dal pozzo principale, Campo de’ Fiori e Argentina dalle discenderie ai lati della chiesa, evitando consistenti attraversamenti del Corso Vittorio.
- Nelle piazze all’esterno saranno visibili solo i corpi delle discenderie (ascensori o scale mobili).
Fatti salvi tutti i benefici della fermata “baricentrica”, qualora per sua realizzazione emergessero impedimenti oggettivi e non risolvibili, la seconda scelta cadrebbe sulla sola Argentina, da realizzarsi in sostituzione di Chiesa Nuova. Già autorizzata dal CIPE, , potrebbe essere realizzata a finanziamento invariato e richiederebbe un coordinamento progettuale e realizzativo con l’ultima tratta del TVA, al fine di gestire il servizio tranviario in modo quanto più possibile indolore per l’utenza.
La soluzione offrirebbe una copertura buona e abbondante nella zona d’interesse (sia pure meno efficace della “baricentrica”) e manterrebbe l’effetto di “sgravare” Venezia dai flussi turistici.
La soluzione offrirebbe una copertura buona e abbondante nella zona d’interesse (sia pure meno efficace della “baricentrica”) e manterrebbe l’effetto di “sgravare” Venezia dai flussi turistici.
Inoltre la vicinanza con l’Area Sacra di largo di Torre Argentina può essere ben sfruttata per concepirla come fermata archeologica con accesso diretto alle rovine, così da accompagnare il viaggio con un’esperienza culturale di grande effetto (Fig. 13).

13 – Vista della fermata Argentina dal progetto preliminare del 2020 di Roma Metropolitane.
È ancora possibile modificare il progetto definitivo, giacché necessita di essere comunque armonizzato con quello della tratta T1. Questo concede qualche mese per poter introdurre una stazione baricentrica in sostituzione di Chiesa Nuova, a finanziamento invariato, spostando i fondi già previsti per quest’ultima.
Piazza Sant’Andrea della Valle (come largo di Torre Argentina) ha un rischio archeologico. La Soprintendenza ha effettuato una campagna di sondaggi e nel 2007 ha riportato la presenza di strutture di età romana.
Va però considerato che da allora è stato istituito il “prontuario archeologico”, e si è proceduto con la catalogazione, lo smontaggio e la ricollocazione di strutture anche non precedentemente note e di grande estensione, come accaduto nei cantieri di Porta Metronia e del sottopasso di Piazza Pia.
Si dovrà richiedere alla Soprintendenza di rivedere la prescrizione del 2007 alla luce dei progressi fatti in questi anni e del collaudato nuovo modus operandi, che si è nel frattempo affinato. Un sistema che sta continuando a produrre meravigliose stazioni ipogee ove esporre e valorizzare reperti che altrimenti nessuno potrebbe conoscere.
Va però considerato che da allora è stato istituito il “prontuario archeologico”, e si è proceduto con la catalogazione, lo smontaggio e la ricollocazione di strutture anche non precedentemente note e di grande estensione, come accaduto nei cantieri di Porta Metronia e del sottopasso di Piazza Pia.
Si dovrà richiedere alla Soprintendenza di rivedere la prescrizione del 2007 alla luce dei progressi fatti in questi anni e del collaudato nuovo modus operandi, che si è nel frattempo affinato. Un sistema che sta continuando a produrre meravigliose stazioni ipogee ove esporre e valorizzare reperti che altrimenti nessuno potrebbe conoscere.
Del resto, la stessa Soprintendenza ha più volte considerato i cantieri della Metro C in centro una straordinaria opportunità per scavare e studiare stratigrafie altrimenti non raggiungibili con le normali tecniche. Uno strumento unico per arricchire il vasto patrimonio di conoscenze del nostro passato.
Qui il documento da scaricare, con l’articolo in pdf
Metro C – la baricentrica per l’ansa barocca
L'articolo
Metro C: la “baricentrica” per l’ansa barocca
proviene da La Metrovia
.