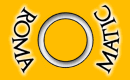Lunedì 30 Giugno 2025 16:06
Dall’Anatolia a Roma: storia e culto della Magna Mater
Dall’Anatolia a Roma: storia e culto della Magna Mater
La visita della interessante mostra “Magna Mater tra Roma e Zama” (6 giugno-5 novembre 2025), allestita in diversi ambienti del Parco archeologico del Colosseo (Uccelliere Farnesiane, Ninfeo della Pioggia, Curia, Tempio di Romolo, Museo del Foro) mi ha spinto ad approfondire l’argomento con l’obiettivo di stimolarne la visita dal vivo a quanti mi leggono. La […]
Dall’Anatolia a Roma: storia e culto della Magna Mater
#musei mostre monumenti #attis #cibele #kubaba #magna mater #maria teresa natale #sec.
leggi la notizia su www.appasseggioblog.it/
Dall’Anatolia a Roma: storia e culto della Magna Mater
La visita della interessante mostra “Magna Mater tra Roma e Zama” (6 giugno-5 novembre 2025), allestita in diversi ambienti del Parco archeologico del Colosseo (Uccelliere Farnesiane, Ninfeo della Pioggia, Curia, Tempio di Romolo, Museo del Foro) mi ha spinto ad approfondire l’argomento con l’obiettivo di stimolarne la visita dal vivo a quanti mi leggono.
La storia delle grandi dee madri del Vicino Oriente e del Mediterraneo ha radici antichissime. Tutto ha inizio con Kubaba, figura storica realmente esistita intorno al 2500 a.C. nella città sumera di Kish. Inizialmente regina, Kubaba fu talmente venerata da essere in seguito divinizzata, diventando una delle prime rappresentazioni della dea madre nelle culture mesopotamiche e anatoliche. Il suo culto si diffuse e si trasformò nel tempo, venendo accolto anche dagli Ittiti e dagli Hurriti, che ne conservarono l’aspetto regale e materno, raffigurandola stante o seduta su un trono, con un aspetto solenne e regale. Tiene spesso in mano una coppa o un melograno, simboli di fertilità, regalità o abbondanza. Le sue vesti sono ampie e riccamente decorate, talvolta con un copricapo o un diadema. Il suo portamento è quello di una sovrana composta, più simile a una regina divinizzata che a una dea della natura.
![Kubaba in una stele in basalto conservata presso il British Museum [Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/Goddess_Kubaba-British_Museum_SOC_14_SOC_10-IMG_3935-white.jpg)
Kubaba in una stele in basalto conservata presso il British Museum [Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0]Alcuni secoli più tardi, in Anatolia centrale, nacque il culto di Kybele (anche nota come Kubele o Cubele), una potente dea della natura e delle montagne, protettrice degli animali selvaggi e simbolo di fertilità. Il suo culto si sviluppò nella regione della Frigia intorno al 1200-800 a.C. e si strutturò in rituali estatici, spesso connotati da forte carica emotiva e simbolica. Sebbene distinta da Kubaba, Kybele potrebbe averne ereditato alcuni tratti attraverso la tradizione religiosa anatolica.
La sua iconografia è più complessa e suggestiva: appare spesso seduta tra due leoni, oppure su un carro da loro trainato, chiaro simbolo del suo dominio sulla natura selvaggia. Indossa la caratteristica corona turrita, modellata come una cinta muraria, che rappresenta il suo potere sulle città e sulla civiltà. Porta con sé un tamburo e una patera per le libagioni sacre. L’abbigliamento è tipicamente orientale, e il suo aspetto comunica una forza primordiale, strettamente legata al ciclo vitale.
![Ankara, Museo delle Civiltà anatoliche, Statua di Cibele, calcare, metà VI sec. a.C. [Foto realizzata presso la mostra 'Roma e Zama': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6578.jpg)
Ankara, Museo delle Civiltà anatoliche, Statua di Cibele, calcare, metà VI sec. a.C. [Foto realizzata presso la mostra ‘Roma e Zama’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Nel mondo greco, il culto di Kybele venne adottato e trasformato. I Greci cominciarono a chiamarla Mētēr Megálē (“Grande Madre”) a partire dal VI-V secolo a.C., integrandola nel loro pantheon e associandola a figure come Demetra. I suoi riti misterici, caratterizzati da musica, danze frenetiche e pratiche orgiastiche, la resero una divinità marginale ma affascinante nel panorama religioso ellenico. Anche qui viene rappresentata su un trono affiancata da leoni, ma il suo volto si fa più idealizzato, meno selvaggio. Può essere raffigurata accompagnata da fiaccole o da un tirso, bastone sacro usato anche nei culti dionisiaci, segno dell’intreccio tra i misteri della fertilità e le forze della rinascita. I contorni orientali vengono attenuati: la figura si fa più serena, rituale, simbolo di mistero e maternità universale. E cosa successe a Roma?
Fin dal 218 a.C. il cartaginese Annibale, forte di un esercito di almeno sessantamila uomini accompagnati da una quarantina di elefanti stava perseguendo l’obiettivo di indebolire Roma a vantaggio della madrepatria. Dopo aver mietuto numerose vittorie sul Ticino, sul Trebbia, presso il Lago Trasimeno e a Canne, i cartaginesi si videro sconfitti dalle legioni romane nel 207 lungo il fiume Metauro e la loro situazione si capovolse: tre anni dopo Publio Cornelio Scipione portò la guerra in Africa direttamente contro Cartagine. Stiamo parlando della Seconda Guerra Punica che si concluse con la battaglia di Zama nel 202 a.C. dove Scipione sconfisse definitivamente Annibale grazie a una tattica superiore, all’appoggio di cavalleria numidica e alla stanchezza delle truppe avversarie.
A seguito dei trattato di pace tra i due popoli, Cartagine dovette rinunciare a tutti i suoi territori fuori dall’Africa; le fu proibito di intraprendere guerre senza il permesso di Roma, dovette pagare una pesante indennità di guerra e consegnare quasi tutta la flotta militare. Era iniziato il declino di Cartagine, che rimase città potentissima dal punto di vista commerciale, ma politicamente e militarmente ridotta a uno stato vassallo.
Per tornare al nostro racconto, concentriamoci su quanto avvenne nel 204 a.C., quando i Romani, dopo aver consultato i Libri Sibillini nel Tempio di Giove Ottimo Massimo in Campidoglio, presero la decisione di portare a Roma il betilo aniconico, simbolo di Kybele, conservato nel santuario di Pessinunte in Frigia (Tito Livio, Ab Urbe Condita, Libro 29, X). Speravano in tal modo di ottenere il favore divino contro Annibale.
![Localizzazione della Frigia in Anatolia [Immagine: Wikimedia Commons]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/Mappa_Asia_Minore.jpg)
Localizzazione della Frigia in Anatolia [Immagine: Wikimedia Commons]Dopo una trattativa con Attalo I di Pergamo, alleato dei Romani e abile diplomatico, la pietra sacra, di forma ovoidale e appuntita, che gli antichi ritenevano giunta dal cielo (forse un meteorite), venne imbarcata. Il viaggio fu lungo, ma alla fine l’imbarcazione giunse al porto di Ostia.
Tito Livio racconta che:
Si ordinò a Publio Cornelio, accompagnato da tutte le matrone, di recarsi a Ostia per andare incontro alla dea; egli doveva riceverla dalla nave e, appena sbarcata, consegnarla alle matrone che l’avrebbero portata.
Quando la nave giunse alla foce del Tevere, come era stato ordinato, Scipione si spinse al largo, ricevette la dea dalle sacerdotesse e la condusse a terra.
Le matrone più illustri della città – tra cui spiccava il nome di Claudia Quinta – la accolsero; la quale, secondo la tradizione, aveva una reputazione incerta, ma con questo sacro incarico si guadagnò alla posterità una fama di pudicizia ancora più chiara.
Esse, passando il simulacro di mano in mano, e seguite poi dalle altre, con tutta la cittadinanza riversata ad accoglierla, posero incensieri accesi davanti ai portoni e, offrendo incenso, pregarono affinché, volentieri e propizia, la dea entrasse nella città di Roma; poi la condussero nel tempio della Vittoria, che si trova sul Palatino, il giorno prima delle Idi di aprile. E quel giorno divenne festivo. Il popolo numeroso portò doni alla dea nel Palatino, si celebrarono un lectisternio e giochi, chiamati “Megalensia”. (Ab Urbe Condita, XXIX, 10-14)
Quando la nave giunse alla foce del Tevere, come era stato ordinato, Scipione si spinse al largo, ricevette la dea dalle sacerdotesse e la condusse a terra.
Le matrone più illustri della città – tra cui spiccava il nome di Claudia Quinta – la accolsero; la quale, secondo la tradizione, aveva una reputazione incerta, ma con questo sacro incarico si guadagnò alla posterità una fama di pudicizia ancora più chiara.
Esse, passando il simulacro di mano in mano, e seguite poi dalle altre, con tutta la cittadinanza riversata ad accoglierla, posero incensieri accesi davanti ai portoni e, offrendo incenso, pregarono affinché, volentieri e propizia, la dea entrasse nella città di Roma; poi la condussero nel tempio della Vittoria, che si trova sul Palatino, il giorno prima delle Idi di aprile. E quel giorno divenne festivo. Il popolo numeroso portò doni alla dea nel Palatino, si celebrarono un lectisternio e giochi, chiamati “Megalensia”. (Ab Urbe Condita, XXIX, 10-14)
![Antefissa in terracotta di età augustea raffigurante Cibele su nave, Roma, Museo Nazionale Romano [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6604.jpg)
Antefissa in terracotta di età augustea raffigurante Cibele su nave, Roma, Museo Nazionale Romano [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Ovidio aggiunge altre informazioni. Mentre la sacra immagine risaliva il corso del Tevere, l’imbarcazione si incagliò, evento interpretato come un rifiuto della dea a entrare nell’Urbe. Fu allora che la già citata matrona Claudia Quinta intervenne. Riportiamo qui un adattamento narrativo dei verso ovidiani.
Claudia Quinta, che era di nobili origini, seppur bella, non godeva di buona fama: era creduta casta, ma molti dubitavano. Rumori ingiusti l’avevano macchiata, accusata ingiustamente; persino il suo modo di vestire e la lingua chiacchierina avevano indispettito gli anziani. Consapevole della propria innocenza, se ne rideva, ma la folla continua a credere al male. Allora si fece avanti tra le altre donne, raccolse dell’acqua purissima dal fiume, bagnandosi la testa tre volte e alzando tre volte le mani al cielo (i presenti pensarono che fosse impazzita): poi, piegata in ginocchio, fissò la statua divina e, con i capelli sciolti, recitò questa preghiera: “O generosa Madre degli dei, ascolta questa preghiera, con la condizione che io, se sarò ritenuta colpevole d’aver mancato di castità, accetterò il tuo giudizio e, da dea vincitrice, pagherò con la vita; ma se sono innocente, concedimi un segno della mia vita: lascia che le mie mani castamente trascinino la nave.” Detto questo, tirò leggermente la cima della nave: la dea si mosse, seguì il suo gesto, e da quel momento un suono di gioia si levò fino alle stelle. (Fasti, IV, v. 305-344)
Questo episodio doveva simboleggiare il favore divino nei confronti della dea che stava per giungere in città. Sempre in base alle fonti (Ovidio, Livio, Strabone, Plinio il Vecchio), sappiamo che l’imbarcazione in lenta risalita lungo il Tevere, fece diverse soste durante le quali venne bruciato dell’incenso e sacrificata una giovenca immacolata. Là dove l’Almone si gettava nel Tevere, un sacerdote canuto, vestito di porpora, lavò la dea e i sacri oggetti nell’acqua dell’affluente. I seguaci esultavano, le tibie impazzite risuonavano e si sentivano battiti di mani su tamburi di pelle taurina. Claudia avanzava in testa, con il volto radioso dalla gioia per la sua finalmente riconosciuta innocenza e la dea medesima, seduta su un carro, fu introdotta a Roma attraverso la Porta Capena.
Dalla suddetta narrazione possiamo desumere alcune informazioni interessanti. Quando il sacro betilo giunse sul Palatino fu collocato all’interno del Tempio della Vittoria (Aedes Victoriae) nei pressi delle cosiddette Capanne di Romolo, in una posizione strategica con vista sul Circo Massimo. Era stato costruito nel 294 a.C. dal console Lucio Postumio Megello, come voto per una vittoria militare nella Terza Guerra Sannitica e serviva come luogo di culto per celebrare le vittorie militari e rendere omaggio alla dea che garantiva il trionfo romano.

L’11 aprile del 191 a.C., invece, venne dedicato un nuovo tempio destinato al culto della Magna Mater, assimilata a Cibele, proprio accanto al tempio della Vittoria. Oggi è ridotto a un ammasso di ruderi di difficile lettura per i non addetti ai lavori. Potete localizzarne il basamento al di sotto di un boschetto di lecci. L’edificio era in stile ellenistico a pianta rettangolare realizzato inizialmente in pietra locale e successivamente restaurato con marmi pregiati dopo gli incendi del 111 e del 3 d.C.
![Resti archeologici del tempio della Magna Mater sul Palatino [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6568.jpg)
Resti archeologici del tempio della Magna Mater sul Palatino [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Le ricostruzioni moderne suggeriscono un tempio prostilo con colonne corinzie e una cella rialzata, accessibile tramite una scalinata monumentale. Il suo aspetto è conosciuto grazie a una raffigurazione presente su un rilievo in marmo murato sulla facciata posteriore di Villa Medici.
![Villa Medici, rilievo con la facciata del tempio della Magna Mater [Foto: Wikimedia Commons, by Sailko, CC BY 3.0]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/Controfacciata_di_villa_medici_rilievi_romani_10.jpg)
Villa Medici, rilievo con la facciata del tempio della Magna Mater [Foto: Wikimedia Commons, by Sailko, CC BY 3.0]Il betilo si trovava in una cella del tempio, probabilmente su un basamento o su un altare, ma purtroppo non si sa che fine abbia fatto: potrebbe essere stato frantumato o disperso dai cristiani in quanto oggetto pagano, esser stato reimpiegato in qualche edificio tardoantico o medievale oppure, chissà, potrebbe ancora essere sepolto sotto gli strati archeologici del Palatino.
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la statua del dio Almone nel Ninfeo di Egeria, all’interno del Parco della Caffarella, ricordi la forma e il simbolismo della pietra sacra di Pessinunte. Tuttavia, si tratta di un parallelismo iconografico e simbolico, non di un’identificazione diretta o certa.
![Parco della Caffarella, Ninfeo della Ninfa Egeria, statua del dio Almone [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_2396.jpg)
Parco della Caffarella, Ninfeo della Ninfa Egeria, statua del dio Almone [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Certo è che pur essendo una divinità straniera, la Cibele frigia venne benevolmente accolta nel cuore della città perché proveniva dalla terra di origine di Enea, che gli aveva garantito protezione durante la fuga.
![Napoli, Museo Archeologico Nazionale, dettaglio di rilievo con approdo della nave di Enea da Gaeta, marmo bianco, II sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6011.jpg)
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, dettaglio di rilievo con approdo della nave di Enea da Gaeta, marmo bianco, II sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Iconograficamente, le rappresentazioni romane della Magna Mater mantengono la corona turrita, i leoni e il tamburo sacro, ma le conferiscono un aspetto ancora più maestoso e sacrale. La dea è raffigurata come una madre imperiale, in vesti sontuose, a volte con una chiave in mano – simbolo del potere sulla vita e sulla morte – oppure accanto a scene rituali complesse come il taurobolium, il bagno di sangue del toro sacro. La sua immagine si inserisce perfettamente nella religione ufficiale romana: è una divinità potente e ordinatrice, integrata nei valori dello Stato ma con radici profonde e misteriche.
In occasione della dedica del tempio, vennero istituiti anche i Ludi Megalesi (Megalensia) che, ogni anno, si svolgevano ad aprile, e includevano sacrifici, processioni e rituali sacri sul Palatino, ma anche rappresentazioni teatrali, tragedie e commedie, nelle aree del Foro Romano, del Circo Massimo o in teatri lignei montati per l’occasione.
![Dettaglio di un coperchio di sarcofago con la processione della Magna Mater conservato presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6618.jpg)
Dettaglio di un coperchio di sarcofago con la processione della Magna Mater conservato presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]I riti non potevano essere officiati da cittadini romani, ma venivano officiati dai Galli, sacerdoti della dea autocastrati che si esibivano in danze e atti di fervore mistico, a suon di tamburi, flauti e cembali. La castrazione era vista come un atto di totale devozione alla dea, ispirato al mito di Attis, giovane amato da Cibele, che si evirò in un impeto di follia sacra.
![Roma, Musei Capitolini, Rilievo con sacerdote di Cibele da Velletri in marmo lunense, età adrianea [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6631.jpg)
Roma, Musei Capitolini, Rilievo con sacerdote di Cibele da Velletri in marmo lunense, età adrianea [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]L’Archigallo era il sommo sacerdote del culto di Cibele a Roma. Come gli altri Galli, portava abiti femminili colorati, monili e gioielli e si truccava. Questo travestimento rituale serviva a trascendere i confini del genere, rendendolo simbolicamente adatto a comunicare col divino.
![Statuetta di archigallo in calcare bianco, da Zama, III secolo d.C. [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6316.jpg)
Statuetta di archigallo in calcare bianco, da Zama, III secolo d.C. [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]I Ludi Megalesi, celebrati fino all’ufficializzazione del Cristianesimo nel IV secolo, rappresentano pertanto l’apertura di Roma ai culti orientali e alla loro influenza crescente nel tardo periodo repubblicano. L’aristocrazia romana era però disturbata da alcuni aspetti del culto: l’auto-evirazione in stato di trance religiosa effettuata dai Galli, le danze estatiche, le autoflagellazioni. Pertanto, il Senato romano impose diverse limitazioni: i cittadini romani non potevano diventare sacerdoti del culto; era proibita l’evirazione per i Romani; il culto veniva tollerato, ma con moderazione. Secondo Cicerone, il culto orientale metteva in crisi l’ordine razionale e patriarcale della religione romana.
I ludi sono stati resi particolarmente puri, solenni e religiosi dall’uso e dalle norme, in tali ludi per la prima volta il famoso Publio Africano, console per la seconda volta assegnò il posto al Senato davanti al consesso (posti a sedere) del popolo… schiavi rappresentarono questi spettacoli, schiavi vi assistettero, infine i ludi Megalensi furono tutti degli schiavi sotto questo edile.(De haruspicum responso, 13.23‑25)
Il culto della Magna Mater si diffuse ampiamente nell’Impero romano, e con esso anche templi, altari, aree sacre, edicole votive a lei dedicati sul territorio italico e in tutte le province. L’apice del culto si ebbe tra il I e il III secolo d.C., quando Cibele era venerata insieme ad altre divinità orientali (come Iside e Mitra) in contesti sincretici e misterici.
In mostra, nella Curia, è possibile osservare un piccolo capolavoro: la patera di Parabiago, un sontuoso piatto rituale in argento sbalzato e dorato, decorato con un elaborato rilievo cosmico. Al centro troneggiano Cibele e il suo amante Attis su una quadriga trainata da quattro leoni, circondati da divinità solari, lunari, dal tempo, dalle stagioni e dalle personificazioni di aria, acqua, terra. Probabilmente impiegata come coperchio per un’urna cineraria, la patera aveva la funzione di simboleggiare la rinascita dopo la morte, in linea con il culto misterico di Cibele. Realizzata nella seconda metà del IV secolo d.C., questo prezioso manufatto testimonia il perdurare dei culti pagani a Milano in un’epoca ormai cristiana.
![Milano, Civico Museo Archeologico, Patera di Parabiago, Argento, Seconda metà del IV sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6661.jpg)
Milano, Civico Museo Archeologico, Patera di Parabiago, Argento, Seconda metà del IV sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Non posso però non terminare questo racconto senza parlarvi del mito di Attis, che occupa una posizione centrale nel culto di Cibele. La narrazione si sviluppa attorno alla figura di un giovane pastore frigio, dotato di eccezionale bellezza, il cui destino è profondamente segnato dal rapporto con la dea. Secondo le versioni più diffuse del mito, Attis nacque in modo miracoloso, forse da un albero o da una ninfa fecondata da un frutto sacro, simbolo di fecondità. Fin dalla giovinezza, egli fu consacrato al culto di Cibele, che lo amava non soltanto come suo servitore, ma come manifestazione vivente della forza vitale che la dea stessa incarnava.
![Statuetta in terracotta raffigurante Attis morente, da Zama, età ellenistica [Milano, Civico Museo Archeologico, Patera di Parabiago, Argento, Seconda metà del IV sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6289.jpg)
Statuetta in terracotta raffigurante Attis morente, da Zama, età ellenistica [Milano, Civico Museo Archeologico, Patera di Parabiago, Argento, Seconda metà del IV sec. d.C. [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Il nodo centrale della vicenda si compie nel momento in cui Attis, venendo meno ai vincoli del culto, decide di sposare una donna mortale. Durante le nozze, la dea, offesa da quella rottura del patto sacro, interviene: Attis viene colto da un’improvvisa follia – espressione della volontà divina – e si evira sotto un pino, albero sacro a Cibele. Il gesto è insieme punizione, atto sacrificale e fondamento liturgico.
Il mito non si conclude con la sua morte. Cibele, travolta dal dolore, ottiene dagli dèi che il corpo dell’amato non si decomponga, ma rimanga incorrotto, in una forma di esistenza sospesa tra la vita e la morte. In ciò si esprime il principio ciclico del culto: Attis diviene emblema della vegetazione che muore e rinasce, della natura che si ritira in inverno per rifiorire in primavera.
![Statuetta in terracotta raffigurante Attis disteso su una roccia, da Zama, età imperiale [Foto realizzata presso la mostra 'Zama e Roma': Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6292.jpg)
Statuetta in terracotta raffigurante Attis disteso su una roccia, da Zama, età imperiale [Foto realizzata presso la mostra ‘Zama e Roma’: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]Il dramma mitico di Attis trovava il suo riflesso rituale nei riti della settimana sacra di primavera, celebrati con lamenti, danze estatiche, mutilazioni simboliche e infine una festa di rinascita. In particolare, l’autocastrazione dei Galli, i summenzionati sacerdoti della dea, rappresentava un atto imitativo del sacrificio originario, funzionale al rinnovamento spirituale. Attraverso questo mito, si manifesta una concezione religiosa fondata sul dolore trasformato in rigenerazione, sul sacrificio come via d’accesso a un ordine cosmico più alto.
Questi riti si svolgevano tra il 15 e il 27 marzo, e costituivano un ciclo sacro che rievocava miticamente la morte e rinascita di Attis. L’inizio delle celebrazioni, a carattere propiziatorio e agricolo, era il giorno dell'”Ingresso della canna” (15 marzo, Canna Intrat), in cui venivano portate in processione le canne palustri (simboli del luogo dove Attis era stato trovato o si era rifugiato). Il 22 marzo, evento centrale di tutto il rituale, veniva introdotto nel santuario un pino sacro (Arbor Intrat), addobbato come un corpo funebre. Rappresentava l’albero sotto cui Attis si sarebbe evirato e lasciato morire. Questo atto segnava il momento centrale del lutto rituale. Il giorno successivo, 23 marzo, era il giorno del lamento (Tristitia), un giorno di dolore e lutto, in cui si commemorava la morte del giovane. I fedeli si flagellavano, si strappavano i capelli, e vi era una forte componente emotiva e teatrale. Seguiva il Dies Sanguinis (Giorno del sangue), il 24 marzo, momento culminante del dolore e della violenza rituale. I partecipanti danzavano freneticamente al suono di tamburi e flauti, in uno stato di estasi mistica. Alcuni si autoflagellavano fino a sanguinare. I neofiti che volevano entrare nel sacerdozio si evitavano pubblicamente, in imitazione del sacrificio di Attis. Dopo la tensione dei giorni precedenti, il 25 marzo era il giorno che segnava il ritorno alla gioia (Hilaria): si celebrava la rinascita di Attis, la restaurazione della vita. Era una giornata di festa pubblica, giochi e allegria, a simboleggiare la vittoria della vita sulla morte, l’arrivo della primavera e la rigenerazione del mondo naturale. Il 27 marzo, infine, si teneva il rito finale, detto lavatio Matris Deum, cioè la lavanda della statua della dea Cibele nelle acque del fiume Almo. Il gesto aveva un valore di purificazione rituale, sia per la statua che per i fedeli, e chiudeva il ciclo sacro.
Per concludere, ti invitiamo a visitare il Campo della Magna Mater a Ostia antica, con il Sacello di Attis, a pochi passi da Porta Laurentina. Vi si trova un calco in gesso che lo raffigura sdraiato a seguito dell’evirazione, con il capo raggiato. L’originale sta ai Musei Vaticani e lì si possono ben vedere un melograno e una roncola trattenuti nelle sue mani.
![Ostia antica, Sacello di Attis [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6282.jpg)
Ostia antica, Sacello di Attis [Foto: Maria Teresa Natale, CC BY NC SA]L’ampia area triangolare antistante era certamente dedicata ai riti iniziatici, con sacrifici e aspersione del sangue dei tori. Questa cerimonia, nota come taurobolio, vedeva il celebrante, spesso un iniziato al culto, discendere in una fossa coperta da assi forate su cui veniva sacrificato un toro. Il sangue dell’animale ricopriva il fedele, che emergeva rinato, a simboleggiare la morte e la resurrezione di Attis.
[Maria Teresa Natale]
Dall’Anatolia a Roma: storia e culto della Magna Mater