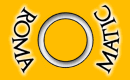Mercoledì 13 Agosto 2025 17:08
Quando Cristo incontrava Maria: l’imponente processione medievale dell’Acheropita nella notte tra il 14 e il 15 agosto
Quando Cristo incontrava Maria: l’imponente processione medievale dell’Acheropita nella notte tra il 14 e il 15 agosto
La processione dell’Acheropita, un rituale medievale di grande fascino e solennità, è documentata a Roma a partire dal pontificato di Leone IV (847-855). Si svolgeva nella notte tra il 14 e il 15 agosto, alla vigilia del Ferragosto, e rappresentava scenograficamente la Dormitio Virginis, ossia l’incontro di Maria con Cristo nel momento della sua morte, […]
Quando Cristo incontrava Maria: l’imponente processione medievale dell’Acheropita nella notte tra il 14 e il 15 agosto
#feste tradizionali #acheropita #basilica di santa maria maggiore #dormitio virginis #innocenzo iii #leone iv #maria teresa natale #medioevo #pio v ghislieri #processioni #roma #salus populi romani #sancta sanctorum
leggi la notizia su www.appasseggioblog.it/
Quando Cristo incontrava Maria: l’imponente processione medievale dell’Acheropita nella notte tra il 14 e il 15 agosto
La processione dell’Acheropita, un rituale medievale di grande fascino e solennità, è documentata a Roma a partire dal pontificato di Leone IV (847-855). Si svolgeva nella notte tra il 14 e il 15 agosto, alla vigilia del Ferragosto, e rappresentava scenograficamente la Dormitio Virginis, ossia l’incontro di Maria con Cristo nel momento della sua morte, prima dell’Assunzione.
Due erano le immagini sacre al centro di questa cerimonia: l’Acheropita e la Salus Populi Romani.
L’Acheropita non è una persona, ma un’icona di Cristo considerata miracolosa, poiché, secondo la tradizione, non fu realizzata da mano umana. Il suo nome deriva dal greco ἀχειροποίητος (a-cheiro-poiētos), che significa “non fatto con le mani”. A Roma, con questo termine si indica il Salvatore Acheropita custodito nel Sancta Sanctorum, l’antica cappella privata dei papi nel complesso del Laterano, all’epoca sede del Patriarchio.
Si tratta di un pannello ligneo, oggi rivestito quasi interamente da una lamina d’argento dorato, che raffigura Cristo in trono: il volto frontale, lo sguardo austero, la mano destra alzata in segno di benedizione e la sinistra a reggere un rotolo del Vangelo. Lo stile richiama l’arte bizantina. Secondo la leggenda, l’opera fu iniziata da un pittore e completata miracolosamente da un intervento divino o angelico. Gli studiosi la datano tra il VI e l’VIII secolo, forse di origine bizantina e giunta a Roma in un periodo di stretti legami con Costantinopoli.

Il volto dell’Acheropita è visibile solo in parte: già al tempo di Innocenzo III (1198-1216) venne coperto da una lamina d’argento dorato, decorata a sbalzo con vesti, nimbo e architetture, lasciando scoperti soltanto i tratti ritenuti più sacri. L’icona presenta anche un foro all’altezza del ginocchio e uno sportellino ai piedi, utilizzati per la lavanda rituale. L’aggiunta della copertura argentea andava considerata come un atto di onore e protezione, che nel tempo accrebbe il senso di venerazione: i fedeli non vedevano un’opera completa, ma il “volto vivente” di Cristo, sospeso tra visibile e invisibile, un dettaglio che avvicina l’Acheropita al Cristo musivo dell’abside della basilica lateranense.

La Salus Populi Romani è una delle icone mariane più venerate al mondo. Il nome significa “Salvezza del Popolo Romano” e riflette la credenza che la Madonna, attraverso questa immagine, abbia protetto Roma nei momenti di pericolo: fu invocata nel Medioevo e nel Rinascimento contro guerre e calamità, e nel 1837 papa Gregorio XVI la fece uscire per la fine di un’epidemia di colera.
. Secondo la leggenda, fu dipinta da San Luca su una tavola proveniente dalla casa di Maria a Nazareth; storicamente è attestata almeno dal IX secolo e custodita attualmente nella Cappella Paolina della basilica di Santa Maria Maggiore.

L’icona, tanto cara a papa Francesco Bergoglio, è dipinta a tempera su tavola: Maria regge Gesù Bambino sul braccio sinistro; il Bambino benedice con la destra e tiene un libro nella sinistra. Gli studiosi la collocano in un arco temporale molto ampio, compreso dal V al XIII secolo.
Nel Museo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore è esposta la custodia originale dell’icona, una cassa in ottone e bronzo dorato (a sinistra nell’immagine sottostante), commissionata da papa Paolo V Borghese (1605-1621), sostituita nel 2018 da una teca moderna atta a garantire la conservazione del prezioso manufatto. Nello stesso museo è esposto anche un piccolo altare in legno, realizzato per ospitare i ritratti di Maria nelle sembianze della Salus Populi Romani e Gesù, realizzati come incisioni su seta. Il manufatto venne commissionato dal principe Paolo Borghese, pronipote di Paolo V, intorno al 1640.

Nello stesso museo è esposto anche un olio su tavola della prima metà del Seicento, di pittore ignoto, che raffigura San Luca che dipinge la Salus Populi Romani.

La processione dell’Acheropita aveva un forte carattere mariano e finì per inglobare quelle della Natività, della Candelora, dell’Annunciazione e dell’Assunzione, istituite da papa Sergio I (687-701).
Intorno al 1140, il cronista Benedetto Canonico racconta che la processione partiva dal Laterano, attraversava il Foro fino alla chiesa di Sant’Adriano (l’antica Curia Iulia), raggiungeva Santa Maria Maggiore e, il mattino seguente, faceva ritorno al Laterano.
Il momento culminante si svolgeva nella veglia notturna a Santa Maria Maggiore, quando l’Acheropita veniva affiancato alla Salus Populi Romani, rievocando simbolicamente la dormizione della Vergine. Questo tema, caro all’iconografia bizantina, è presente anche nel mosaico absidale della basilica.

Le origini di questa celebrazione affondano in tradizioni orientali: la Dormitio era già festeggiata nel VI secolo e a Costantinopoli si teneva una processione all’alba, cui partecipava anche l’imperatore.
In un primo tempo la processione era rigidamente coordinata dal clero pontificio, ma col passare degli anni la gestione passò a confraternite locali. Prima furono coinvolti gli Ostiarii – custodi legati alle basiliche patriarcali e al Laterano, membri del clero assistente del papa – e in seguito la prestigiosa Confraternita del Gonfalone.
Questa confraternita nacque nel XIII secolo come Compagnia dei Raccomandati della Madonna presso Santa Maria in Aracoeli. Nel 1264 papa Clemente IV (1265-1268) concesse loro il privilegio di portare in processione un gonfalone con l’immagine della Vergine per invocare la protezione di Roma: da qui il nome. Già nel XV secolo la confraternita, insieme alle magistrature comunali e alle corporazioni delle arti, rappresentava un’espressione solenne della società romana.
Le corporazioni partecipavano alla processione rispettando un ordine preciso, pena multe salate. Ognuna era rappresentata da un talamo: un massiccio supporto ligneo portato a spalla da otto o dodici uomini, carico di torce imponenti in cera o in legno e stoppa imbevuta di resina o pece. Sul talamo erano dipinti il mestiere e gli strumenti della corporazione, così da renderla immediatamente riconoscibile. Nella processione ferragostana circa quaranta talami illuminati precedevano l’Acheropita: quanto più si era vicini all’icona, tanto più prestigio si aveva. Macellai, mercanti e banchieri occupavano le prime posizioni; tavernieri e acquaioli chiudevano il corteo.
Nel 1525, Marco Antonio Altieri, membro della Confraternita del Gonfalone, descrive così un momento della processione:
“Retrovandomi vicino al Cavallo Eneo presso San Giovanni, per vedere e venerare la devotissima immagine del nostro Salvatore, come in Santa Maria di mezzo Agosto tra noi ogni anno si costuma, mi accorsi, non molto lontano, dell’innumerevole moltitudine di talami, facole, caporioni, luminarie senza fine di confraternite, numero eccessivo di sacerdoti con molti religiosi, seguiti a piedi e a cavallo da grandissima folla di brigate.”
Un’epigrafe murata nello Scalone monumentale dei Musei Capitolini reca inciso l’ordine di partecipazione delle corporazioni alla processione nella metà del Cinquecento.
Nel 1566 papa Pio V Ghislieri (1566-1572) soppresse la processione, considerata fonte di disordini, ma già a partire dal Giubileo del 1575 e la nascita del percorso delle Sette Chiese, si svilupparono nuovi itinerari devozionali.
Dopo la soppressione, la Confraternita del Salvatore si impegnò a conservarne il ricordo attraverso testi eruditi e opere artistiche. Un documento visivo prezioso si trova nell’antico Ospedale di San Giovanni in Laterano, in un edificio tra la chiesa di Sant’Andrea, l’ingresso del nosocomio e la spezieria, dove in passato si trovava anche la sede della Confraternita del Gonfalone (oggi cappella delle monache).
Intorno al 1614, in quella sede, furono realizzati undici dipinti che illustravano le varie fasi della processione, oltre al riquadro dei donatori. Le pitture erano disposte in senso orario lungo la fascia superiore della sala; oggi ne rimangono dieci. Vi proponiamo la sequenza:
- I guardiani del SS. Salvatore vanno da S. Maria in Aracoeli a S. Giacomo al Colosseo [chiesa scomparsa].
- A S. Giacomo al Colosseo i guardiani incontrano il clero lateranense.
- I guardiani e il clero lateranense trasportano il talamo e i ceri da S. Giacomo al Colosseo fino alla cappella del Sancta Sanctorum.
- L’Acheropita viene traslato dalla cappella del Sancta Sanctorum al Campo Lateranense.
- L’Acheropita viene trasportato attraverso il Campo Lateranense fino all’Ospedale di San Giovanni.
- Prima lavanda dei piedi presso l’Ospedale di S. Giovanni.
- Seconda lavanda dei piedi e omaggio ai caporioni presso la basilica di San Clemente.
- Terza lavanda dei piedi a S. Maria Nova e omaggio delle donne ai SS. Cosma e Damiano.
- Quarta lavanda dei piedi e omaggio del Senatore di Roma e dei Conservatoria S. Adriano .
- Dipinto perduto.
- Sesta lavanda dei piedi a S. Giuliano [chiesa scomparsa all’Esquilino] e ritorno dell’Acheropita alla cappella del Sancta Sanctorum.

Oggi della fastosa processione dell’Acheropita restano solo le cronache, le epigrafi e pochi dipinti, frammenti di un rito che univa fede, arte e identità civica. Il suo ricordo continua a raccontare una Roma capace di trasformare la devozione in spettacolo e la liturgia in racconto collettivo. È nella memoria di questi gesti e percorsi che sopravvive l’eco di una delle cerimonie più solenni e amate della città eterna per secoli.
[Maria Teresa Natale]
Per approfondire:
Enrico Parlato,
La storia «postuma» della processione dell’acheropita e gli affreschi seicenteschi della confraternita del Salvatore ad Sancta Sanctorum
, in “Roma Moderna e Contemporanea” 2008, p. 327-335.Quando Cristo incontrava Maria: l’imponente processione medievale dell’Acheropita nella notte tra il 14 e il 15 agosto