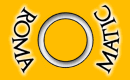Mercoledì 10 Settembre 2025 12:09
Leoncavallo: storia, eredità e controversie di uno spazio autogestito
Per mezzo secolo, il Leoncavallo ha rappresentato una delle realtà più note e discusse della...
#attualità
leggi la notizia su RomaDailyNews
Per mezzo secolo, il Leoncavallo ha rappresentato una delle realtà più note e discusse della scena urbana milanese. Nato come centro sociale occupato, si è affermato nel tempo come laboratorio di cultura indipendente, azione sociale e sperimentazione comunitaria.
Tra entusiasmo e diffidenza, ha lasciato un segno profondo nella città. Oggi, dopo il definitivo sgombero avvenuto nell’agosto 2025, si chiude un capitolo della sua storia. Ma se ne apre un altro: quello della riflessione.
Una lunga storia di autogestione
Fondato nel 1975, il Leoncavallo nacque dall’occupazione di un’ex tipografia. I promotori si proponevano di creare uno spazio libero dai vincoli istituzionali, aperto a iniziative culturali,
mutualistiche e politiche dal basso. L’esperienza si è sviluppata negli anni attraverso attività molto diverse: concerti, dibattiti, mense popolari, corsi di lingua, consultori, sportelli legali, biblioteche autogestite, e un’intensa produzione artistica urbana.
mutualistiche e politiche dal basso. L’esperienza si è sviluppata negli anni attraverso attività molto diverse: concerti, dibattiti, mense popolari, corsi di lingua, consultori, sportelli legali, biblioteche autogestite, e un’intensa produzione artistica urbana.
Dopo vari sgomberi e rioccupazioni, il centro si stabilì nel 1994 in via Watteau, dove rimase fino allo sgombero del 2025. In questo lungo periodo ha operato come Spazio Pubblico Autogestito (da cui l’acronimo S.P.A.), senza finanziamenti pubblici né forme
convenzionali di gestione.
convenzionali di gestione.
Un’offerta culturale ampia e accessibile
Il Leoncavallo si è distinto come uno dei maggiori centri culturali indipendenti in Italia. Ha ospitato centinaia di artisti nazionali e internazionali, spaziando tra generi musicali, arti visive e performance. L’accessibilità economica e la libertà creativa sono stati tratti distintivi apprezzati da un pubblico eterogeneo, soprattutto giovanile.
Molto noti sono anche i murales e le installazioni artistiche che decoravano gli interni ed esterni del centro. Alcune di queste opere sono state riconosciute di interesse culturale dalla Soprintendenza alle Belle Arti.
Le criticità: una questione di percezione
Accanto ai numerosi riconoscimenti culturali e sociali, il Leoncavallo è stato al centro di controversie persistenti. Il nodo principale è sempre stato quello della legalità: il centro ha
operato per decenni in regime di occupazione, senza titolo di proprietà o concessione.
operato per decenni in regime di occupazione, senza titolo di proprietà o concessione.
Questo aspetto ha generato contrasti con le istituzioni e parte dell’opinione pubblica, contribuendo a una percezione ambivalente.
Altri elementi critici segnalati nel tempo riguardano l’impatto ambientale e sonoro degli eventi notturni, la gestione interna percepita come chiusa o poco trasparente, e la convivenza non sempre facile con il contesto urbano circostante. Queste criticità sono state spesso enfatizzate nel dibattito politico e mediatico, a volte in modo polarizzato.
Uno spazio, due sguardi
Il Leoncavallo ha vissuto per anni all’interno di una frattura percettiva ben definita. Chi lo frequentava lo descriveva come un ambiente inclusivo, solidale e creativo, capace di offrire servizi e opportunità là dove mancavano alternative. Chi lo guardava dall’esterno, invece, poteva percepirlo come un luogo ideologicamente connotato, autoreferenziale o in contrasto con le regole comuni.
Questa distanza non è solo una questione di opinioni, ma riflette un problema più profondo: il difficile dialogo tra pratiche sociali informali e le istituzioni urbane, tra forme di cittadinanza attiva e i canoni normativi che regolano l’uso degli spazi pubblici.
Il significato dello sgombero
Lo sgombero del 2025 ha segnato la fine di un ciclo. Dopo oltre trent’anni nella sede di via Watteau, le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento di rilascio dell’immobile, ponendo fine a una lunga vertenza con i proprietari. Alcune opere d’arte sono state messe in sicurezza, ma la struttura è rimasta vuota.
Il dibattito si è riacceso: è giusto che uno spazio così venga rimosso? O è possibile immaginare una sua trasformazione in una
nuova forma, dentro un quadro legale più stabile? Attualmente si discute dell’ipotesi di trasferire l’esperienza del Leoncavallo in un nuovo spazio, con il supporto del Comune. Ma il progetto è ancora lontano dalla realizzazione.
nuova forma, dentro un quadro legale più stabile? Attualmente si discute dell’ipotesi di trasferire l’esperienza del Leoncavallo in un nuovo spazio, con il supporto del Comune. Ma il progetto è ancora lontano dalla realizzazione.
Un’eredità complessa ma significativa
Il Leoncavallo ha incarnato un’idea di città diversa: più partecipata, meno verticale, più sperimentale. È stato un luogo dove si è tentato di dare forma a pratiche di mutualismo urbano e produzione culturale dal basso. Le sue contraddizioni — tra inclusione e chiusura, innovazione e conflitto, cultura e antagonismo — riflettono tensioni presenti in molte metropoli europee.
Oggi, al di là delle posizioni ideologiche, la sua storia pone una domanda più ampia: come possono le città integrare forme di espressione autonoma senza negare il principio di legalità? E quale spazio c’è, concretamente, per esperienze che sfidano i modelli
istituzionali, ma che generano valore sociale? (Bruno Carboniero)
istituzionali, ma che generano valore sociale? (Bruno Carboniero)