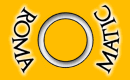Mercoledì 10 Settembre 2025 10:09
Castel Sant’Angelo: seconda parte
In quello che ormai era diventato un castello, presero posto oltre ad armature ed armi bianche stipate nelle varie armerie, anche le armi da fuoco. È il caso di una cannoniera risalente al periodo di papa Alessandro VI Borgia. Questa era affacciata sul cortile di Leone X, chiamata con un termine dell’epoca “bombardella”. Risale alla [...]
L'articolo
Castel Sant’Angelo: seconda parte
proviene da VIVIROMA
.
#alla scoperta di roma #slider
leggi la notizia su VIVIROMA
Questa era affacciata sul cortile di Leone X, chiamata con un termine dell’epoca “bombardella”. Risale alla prima metà del XVI secolo, ed era posta probabilmente su un apertura (oculo) che dava sull’ esterno.
Questa fu rinvenuta tra gli avanzi di una barca bruciata finita sotto Ponte Sant’Angelo durante la fondazione dei muraglioni. Insieme all’arma furono rinvenuti sette mascoli (camere di scoppio per artiglieria; parti amovibili posteriori degli antichi cannoni a retrocarica), alcuni ancora carichi con la palla di ferro all’interno pronta per essere sparata.
Erano tutti completi e dunque formavano un’ artiglieria cerchiata a tiro rapido. L’appellativo “mascolo”, deriva da maschio, allusivo all’organo sessuale maschile, essendo questa parte dell’ ordigno finalizzata ad essere inserita in un incavo.
La bombardella ritrovata, servì da modello per costruirne tre copie, in seguito posizionate sulla terrazza del Bastione San Giovanni. Una di queste è ancora visibile sulla terrazza del Bastione San Marco.

Un’altra bombardella fu trovata invece nella Sala di Giustizia, era accompagnata da un testo risalente al 1498 che ne riportava l’acquisto su cui si legge: “due barconi per la difesa di Castel Sant’Angelo”. Si ipotizza che fossero ancorati uno all’imbocco e l’altro allo sbocco del fossato. Armati come bombardella da barca, di cui si hanno diversi esempi nel museo del castello. È possibile che facessero parte di un preciso sistema difensivo. Nella Sala di Giustizia ne verranno in seguito posizionate ben cinque.
Il mausoleo fu soggetto a continue trasformazioni. Cambiando destinazione ed uso, subì continui e frequenti mutamenti, tanto che del XV secolo esistono solo ipotesi ricostruttive sul suo aspetto, tutte esclusivamente formulate su antiche fonti grafiche.
Sicuramente c’era il corpo cilindrico e il basamento quadrato della Mole, che misurava 89 metri per lato e 15 di altezza. Al di sopra c’era la costruzione cilindrica alta 20 metri e rivestita completamente di marmo. All’interno di questa si trovava la camera sepolcrale ancora ben conservata e accessibile attraverso la rampa elicoidale.




In un plastico esposto nella mostra, è possibile vedere delle piccole piramidi che coronavano il basamento e che corrispondevano ad alcune fessure atte ad illuminare ed arieggiare la cella. Il cilindro era coperto da un tumulo di terra che accoglieva dei filari di cipressi ed era circondato da statue e colonne. La sommità era sormontata da un imponente quadriga di bronzo guidata da Adriano. L’uso difensivo del castello portò però all’eliminazione delle parti decorative quali le colonne, le statue e ovviamente la quadriga, probabilmente fusa per farne dei cannoni.
Alcuni torrioni angolari che erano già stati edificati al tempo di Niccolò V (1447-1455), furono ampliati e fortificati dal Borgia, che incaricò dell’opera Antonio da Sangallo il vecchio. Questi realizzò quattro imponenti bastioni con i due frontali collegati tra loro da una nuova alta cinta muraria che si affacciava sul Tevere. A questo punto Sangallo intervenne affinché le acque del fiume alimentassero il fossato che cingendo il castello avrebbe creato un ennesima difesa difficilmente superabile.
Va ricordato che strutture di questo genere erano già di per sé difficilmente espugnabili. Uno dei sistemi tra i più efficaci per aprirne una breccia, era minarne le mura. Venivano scavate delle gallerie realizzate da minatori esperti, questi quando raggiungevano i basamenti delle mura, toglievano tutta la terra sulla quale queste poggiavano, puntellandole con pali di legno a cui poi davano fuoco. I pali bruciando cedevano e facevano mancare il sostegno al muro difensivo, che cosi finiva per crollare. Più avanti si sarebbe usata la polvere da sparo, ancora più efficace.
L’acqua nei fossati serviva proprio a complicare se non ad impedire il lavoro dei minatori. Il peso dell’acqua sulle gallerie rischiava di farle crollare, le infiltrazioni d’acqua rendevano lo scavo fangoso e la profondità del fossato vanificava l’idea di poterci passare sotto.
Papa Borgia incaricò poi il Pinturicchio di decorare la sua dimora con pitture in stile grottesco. Le pitture grottesche sono decorazioni murali fantasiose e bizzarre, propongono soggetti ibridi, incroci tra animali, piante, o figure umane, anche mostruose. I soggetti si intrecciano con le cornici su sfondi monocromi. Il termine “grottesco” deriva dalla loro scoperta alla fine ‘400. Si trattava di case sfarzose e ricche come la Domus Aurea di Nerone o la Domus Transitoria di Traiano, che rimaste sepolte sotto terra ricordavano delle grotte. Pittori e studiosi incuriositi, si calavano all’interno copiandone i disegni delle pareti. A questa tipologia pittorica si ispirarono artisti rinascimentali come Raffaello e Michelangelo diffondendola in tutta Europa.


Lo stile è una rielaborazione del terzo e quarto stile pompeiano, che si distingue per la sua simmetria, delicatezza e l’inserimento di elementi naturalistici e fantastici.
Il portico invece presentava sei scene affrescate dedicate alla pacificazione di Alessandro VI con il re di Francia Carlo VIII avvenuta nel 1495.
Il complesso borgesco però fu smantellato nel 1628 da Urbano VIII (1623-1644), che lo considerava inutile ai fini difensivi. Convinto a ragione di ciò, per prevenire le critiche dei posteri, fece apporre un’iscrizione che riportava la motivazione dell’abbattimento della struttura.
L’aspetto Cinquecentesco del castello invece è visibile in alcuni dipinti che ritraggono l’apparizione dell’Arcangelo Michele. Uno di questi, è un quadro copia da Ventura Salimbeni il cui originale è conservato nella basilica di San Pietro a Perugia.
Questo mostra in primo piano il pontefice e i romani sorpresi dalla visione dell’Angelo, sul fondo il castello presenta ancora le aggiunte volute dal Borgia.
La scena dell’apparizione fu riprodotta da numerosi artisti tra cui Lorenzetti, Beccafumi, Zucchi e De Vecchi.
L’apparizione si ebbe durante un periodo difficile per il pontificato di Gregorio I Magno (590-604). Dopo tre giorni di processioni dirette verso la tomba dell’apostolo Pietro, il 29 agosto del 590, apparve l’Arcangelo Michele mentre riponeva nel fodero la sua spada fiammeggiante. Questo atto simbolico determinava la fine delle sventure che affliggevano l’Urbe: la peste, la conseguente carestia e la piena del Tevere.
L'articolo
Castel Sant’Angelo: seconda parte
proviene da VIVIROMA
.