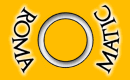Lunedì 9 Novembre 2020 17:11
Gli obelischi (e non solo) dell’Iseo Campense a Roma
L’itinerario che seguiremo si concentra in Campo Marzio, quarto rione di Roma dove, tra vicoli e piazze famose in tutto il mondo, scopriremo alcuni obelischi antichi e reperti archeologici visibili a cielo aperto appartenuti all’Iseo Campense, il tempio dedicato a Iside e a Serapide, risalente al I ...
L'articolo
Gli obelischi (e non solo) dell’Iseo Campense a Roma
proviene da Rome With Suzy
.leggi la notizia su Rome With Suzy

Moneta di Vespasiano del 71 d.C. con il Tempio di Iside in Campo Marzio

In blu l’area dell’Iseo Campense

I tre frammenti della Forma urbis Severiana dell’Iseo Campense
L’itinerario che seguiremo si concentra in Campo Marzio, quarto rione di Roma dove, tra vicoli e piazze famose in tutto il mondo, scopriremo alcuni obelischi antichi e reperti archeologici visibili a cielo aperto appartenuti all’Iseo Campense, il tempio dedicato a Iside e a Serapide, risalente al I secolo a.C., la cui ubicazione è testimoniata da molti scrittori antichi come Cassio Dione, Giovenale, o anche da tre frammenti della Forma Urbis Severiana, da una moneta del 71 d.C. di Vespasiano, dai rilievi della tomba monumentale degli Haterii del II secolo d.C., da Giuseppe Flavio e dalla devozione di molti imperatori al culto di Iside. La civiltà egizia ha una lunga storia. Inizia 4 mila anni prima di Cristo mentre la storia di Roma inizia nell’VIII secolo a.C. I rapporti politici e di alleanza tra le due potenze sono attestati fin dal III secolo a.C., ma tra il 51 e il 30 a.C. il Regno d’Egitto diventa uno dei più acerrimi nemici di Roma: Cleopatra VII, infatti, della dinastia dei Tolomei, spera di dominare l’intero Mediterraneo. È con lei che la storia egizia si fonde con quella di Roma. A Roma è già entrato un culto ermetico, misterioso, esoterico: quello di Iside, accompagnato dal culto del suo sposo, Serapide, che assimilò la figura di Osiride, in un sincretismo ideato da Tolomeo I nel IV secolo a.C., conciliando in un unico dio le caratteristiche greche di Serapide e le caratteristiche egizie di Osiride. Dopo la morte di Giulio Cesare, il culto di Iside non era visto di buon grado dai Senatori ma i Triumviri, nel 43 a.C., promisero di costruire un tempio a lei dedicato in Campo Marzio. Quando Ottaviano prese il nome di Augusto, divenendo il primo imperatore romano della storia, pur non amando i culti orientali, non osteggiò quello di Iside. E’ proprio con Augusto, sotto il cui dominio l’Egitto era stato conquistato, che nasce l’egittomania portando a Roma cimeli di conquista. Gli obelischi ne sono una prova. Roma è la città che conserva il maggior numero di obelischi al mondo, ben 13 e 8 sono originali egizi. Nel 2005 l’obelisco di Axum fu restituito all’ Etiopia. L’obelisco, dal greco obelos, spiedino, è un monumento celebrativo formato da un tronco di piramide alto e stretto, che culmina con una punta piramidale chiamata pyramidion. Gli obelischi antichi venivano ricavati da un unico blocco di pietra (un monolito). La cuspide identificava il benben, la collina primigenia che emerse dall’oceano primordiale sul quale il dio creatore Atum generò se stesso e la prima coppia divina. Ricoperta di lamine dorate brillava illuminata dai raggi solari. L’obelisco simboleggiava il Dio del Sole Ra. L’itinerario che seguiremo si concentra in Campo Marzio, quarto rione di Roma dove, tra vicoli e piazze famose in tutto il mondo, scopriremo alcuni obelischi antichi e reperti archeologici visibili a cielo aperto appartenuti all’Iseo Campense, il tempio dedicato a Iside e a Serapide, risalente al I secolo a.C., la cui ubicazione è testimoniata da molti scrittori antichi come Cassio Dione, Giovenale, o anche da tre frammenti della Forma Urbis Severiana, da una moneta del 71 d.C. di Vespasiano, dai rilievi della tomba monumentale degli Haterii del II secolo d.C., da Giuseppe Flavio e dalla devozione di molti imperatori al culto di Iside. La civiltà egizia ha una lunga storia. Inizia 4 mila anni prima di Cristo mentre la storia di Roma inizia nell’VIII secolo a.C. I rapporti politici e di alleanza tra le due potenze sono attestati fin dal III secolo a.C., ma tra il 51 e il 30 a.C. il Regno d’Egitto diventa uno dei più acerrimi nemici di Roma: Cleopatra VII, infatti, della dinastia dei Tolomei, spera di dominare l’intero Mediterraneo. È con lei che la storia egizia si fonde con quella di Roma. A Roma è già entrato un culto ermetico, misterioso, esoterico: quello di Iside, accompagnato dal culto del suo sposo, Serapide, che assimilerà la figura di Osiride, in un sincretismo ideato da Tolomeo I nel IV secolo a.C., conciliando in un unico dio le caratteristiche greche di Serapide e le caratteristiche egizie di Osiride. Dopo la morte di Giulio Cesare, il culto di Iside non era visto di buon grado dai Senatori ma i Triumviri, nel 43 a.C., promisero di costruire un tempio a lei dedicato in Campo Marzio. Quando Ottaviano prese il nome di Augusto, divenendo il primo imperatore romano della storia, pur non amando i culti orientali, non osteggiò quello di Iside. E’ proprio con Augusto, sotto il cui dominio l’Egitto era stato conquistato, che nasce l’egittomania portando a Roma cimeli di conquista. Gli obelischi ne sono una prova. Roma è la città che conserva il maggior numero di obelischi al mondo, ben 13 e 8 sono originali egizi. L’obelisco, dal greco obelos, spiedino, è un monumento celebrativo formato da un tronco di piramide alto e stretto, che culmina con una punta piramidale chiamata pyramidion. Gli obelischi antichi venivano ricavati da un unico blocco di pietra (un monolito). La cuspide identificava il benben, la collina primigenia che emerse dall’oceano primordiale sul quale il dio creatore Atum generò se stesso e la prima coppia divina. Ricoperta di lamine dorate brillava illuminata dai raggi solari. L’obelisco simboleggiava il Dio del Sole Ra
Obelisco Agonale o Pamphiljo

Obelisco Pamphiljo
L’obelisco di Piazza Navona è conosciuto come obelisco agonale in ricordo degli agonali, ossia dei giochi atletici di origine greca che si svolgevano nello Stadio di Domiziano costruito tra l’81 e il 96 d.C. Faceva parte dell’Iseo Campense, posto tra i due archi monumentali d’entrata e presso l’esedra; ha un’altezza di 16,38 m e con il basamento e la colomba, simbolo araldico dei Pamphilj, supera i 30 m. L’obelisco della Fontana dei Quattro Fiumi è un obelisco ricomposto a quattro facce in granito rosso originariamente aniconico portato da Assuan dall’imperatore Domiziano nel I secolo d.C. Fu realizzato all’epoca di Domiziano imitando i modelli egizi e copiando i geroglifici senza comprenderli. L’imperatore Massenzio (306-312 d.C.) lo spostò e lo fece collocare nel circo della sua villa, tra il secondo e terzo miglio della via Appia Antica dove, nel 1647, fu rinvenuto rotto in 4 pezzi. Innocenzo X bandì un concorso per erigerlo al centro della sua Cavallerizza. Il progetto urbanistico era quello di rappresentare nella piazza, alimentata da poco dall’Acqua Vergine, la magnificenza del suo papato. Tra F. Borromini e G.L. Bernini quest’ultimo ebbe la meglio anche con uno stratagemma concordato con la cognata del papa, Donna Olimpia Maidalchini. Di fatto, il papa si ritrovò il modellino in argento massiccio esposto su di un tavolo che gli piacque al punto tale da licenziare il Borromini. L’obelisco fu eretto nel 1649 e la fontana fu inaugurata il 12 giugno 1651, allagando tutta la piazza per i festeggiamenti. L’obelisco svetta al centro della Fontana dei Quattro Fiumi, opera architettonica complessa barocca voluta da papa Innocenzo X Pamphilj. L’obelisco è conosciuto anche come Obelisco Pamphilio. Famosa è l’opera omonima scritta dal gesuita Athanasius Kircher. Nell’800 il banchiere Giovanni Torlonia, proprietario della zona del Circo di Massenzio, trovò altri frammenti che decise di donare al re Luigi di Baviera. Il pyramidion si trova in Vaticano, diviso in tre pezzi. Riporta Domiziano faraone tra Iside e Thot sul lato nord, Horus e Necbet con corona dell’Alto Egitto sul lato est, Hathor e un’altra divinità con corona del Basso Egitto a sud e infine lui con doppia corona tra Mut, la dea madre, e Amon a sinistra. Bernini e Kircher lavorarono insieme a questo progetto quasi in simbiosi. Tutto ciò che è riprodotto visibilmente è fonte delle idee simboliche di Kircher e della sua fantasia nell’interpretare i geroglifici. Ecco le sue interpretazioni dei falsi geroglifici: sul lato Sud verso la Fontana del Moro cita: “Innocenzo X per la pietra ornata di enigmi nilotici sovrappose ai fiumi che qui sotto scorrono allo scopo di offrire con la magnificenza salutare amenità a chi passeggia, bevanda per chi ha sete, occasione per chi vuole meditare; a Est: i nocivi mostri degli Egizi calca la colomba che portando l’ulivo della pace e delle virtù, coronata di gigli, prendendo per suo trofeo un obelisco in Roma trionfa; verso Ovest Sant’Agnese: Innocenzo X P.M. ampliata e ornata la casa natale dei Pamphilj e liberata la piazza Agonale da inopportuni edifici, la più celebre piazza dell’Urbe nobilitò accrescendone la maestà; a Nord verso via Zanardelli: questo obelisco portato a Roma dall’imperatore Caracalla a lungo rimasto giacente e spezzato tra i ruderi del circo castrense, Innocenzo X P.M. trasferì, restaurò ed eresse nell’anno 1651, settimo del suo pontificato”. Qui risulta l’errore attribuito a Caracalla e al luogo di ritrovamento. Athanasius Kircher, umanista, conoscitore del copto, influenzò dunque il Bernini con le sue teorie di stampo neoplatonico, con riferimenti alla Sapienza egizia e caldea, oltre alla cabala ebraica e allo gnosticismo. Kircher credeva che ci fosse una continuità sapienziale proveniente dall’antico Egitto, dalla tradizione mosaica passante per la cultura greco persiana per giungere al cristianesimo delle origini. In sintesi, l’opera tutta simboleggia la cosmogonia e racchiude in sé ermetismo e zoroastrismo; può essere “letta” secondo una simbologia numerica di stampo platonico e pitagorico, legato alla perfezione divina, alla forma piramidale, o anche da un punto di vista neoplatonico, legato alla dualità di luce e buio, di piena e di secca, di calma e tempesta.
Obelisco Macuteo o della Rotonda o del Pantheon

Obelisco di Ramses il Grande alla Rotonda

Geroglifici di Ramses II sull’obelisco
L’obelisco Macuteo (o del Pantheon o della Rotonda) in Piazza della Rotonda prende il nome dalla Piazza di San Macuto, dove fu trovato nel 1373, a pochi metri di distanza dal sito attuale. Fu eretto davanti alla facciata della Chiesa di San Macuto (o Maclovio, uno dei sette santi fondatori della Bretagna continentale, patrono di Saint Malo, nel VII secolo d.C.) e lì rimase fino al 1711, anno in cui Clemente XI Albani lo fece spostare sulla nuova fontana ideata da Filippo Barigioni, che sostituì la precedente di Giacomo della Porta del 1575. L’obelisco proviene dall’Iseo Campense. È di granito rosso, alto 6,34 metri; con la fontana, il basamento e la croce raggiunge i 14,52 metri. Proviene originariamente da Heliopolis e fu portato a Roma da Domiziano. Una stella Albani in bronzo decora la sommità dell’obelisco. Sulla cuspide vi erano raffigurati i cartigli di Ramses II e su ciascun lato vi è il nome con l’attributo di “figlio di Ra, sua immagine sacra, protettore delle sue creature, colui che moltiplica le sue offerte, costruttore dei monumenti per la casa di Ra, grande per festività come Ra sul trono di Atum”. Risale all’epoca di Ramses II, Ramses il Grande, il re dei re, in carica dal 1279 al 1212 a.C.; egli regnò 75 anni in tutto se si includono gli 8 anni di regno con il padre Seti I. Ebbe una lunga vita: infatti morì a 91 anni. Il suo regno contrassegnò un’epoca, uno stile nelle arti e nei monumenti e fu caratterizzato da eventi politici eccezionali, combattendo contro l’invasione degli Ittiti a Nord (ricordiamo la famosa battaglia di Qadesh del 1296 che finì alla pari e che ha dato vita al primo trattato di non aggressione nella storia) e occupando a Sud i territori della Nubia, assicurando il predominio dell’Egitto sui giacimenti auriferi. Cultore dell’immagine, in Nubia fece costruire sei templi, di cui il più famoso è quello di Abu Simbel, il Tempio Maggiore dedicato ad Amon, costruito tra il 1264 e il 1244 a.C. a sud di Assuan. Accanto vi è il Tempio Minore, dedicato alla moglie Nefertari, “colei per cui il sole risplende”. Il gemello dell’obelisco di Ramsess II è a Villa Celimontana. Intorno al 1530 la parte antistante il Pantheon fu abbellita con due vasche e due leoni egizi in basalto del faraone Nectanebo II, che erano stati ritrovati durante il pontificato di Eugenio IV un secolo prima proprio nel luogo dove esisteva l’Iseo Campense.

I due leoni di Nectanebo II sono ora nel Cortile della Pigna ai Musei Vaticani. Una nota interessante risulta evidenziare che anche i due leoni che si trovano alla base della Cordonata del Campidoglio provengono dall’Iseo Campense, così come due dei leoni che ornano la Fontana di Mosé (o Mostra dell’Acqua Felice), voluta da Sisto V Montalto Peretti.
Obelisco della Minerva


Apries, faraone nominato sull’obelisco della Minerva
L’obelisco della Minerva proviene dall’Iseo Campense, il tempio dedicato a Iside e a Serapide in Campo Marzio. Fu eretto a Sais dal Faraone Apries (o Hophra), in carica dal 589 al 570 a.C., figlio di Psammetico II, appartenente alla 26ma Dinastia Saitica. Abbiamo avuto modo di vedere l’obelisco di Psammetico II, l’obelisco di Monte Citorio. Il suo nome è riportato nella Bibbia in Geremia 14,30. La storia del Faraone Apries è collegata alle invasioni da parte di Nabucodonosor re di Babilonia che, con la distruzione del Tempio di Salomone, causò la prima deportazione del popolo ebraico (Esilio babilonese). Apries, in guerra contro il suo avversario Amasis, la cui statua è stata ritrovata proprio qui ed ora custodita ai Musei Capitolini, venne sconfitto e sepolto nel tempio di Neith e Atum a Sais in Egitto. L’obelisco è un monòlito a quattro facce in granito rosso alto 5,47m, dedicato alle divinità Neith e Atum, patroni della città di Sais, capitale d’Egitto nella XXIV, XXVI e XXVIII dinastia del VI secolo a.C. Fu portato a Roma da Domiziano. I geroglifici riportano il nome del re e gli appellativi di Atum come signore della terra e della vita e Neith déa del tempio dell’ape, colei che è preminente nella terra della vita. Nel 1665 i Domenicani lo trovarono scavando nel loro giardino per costruire un muro. Per tradurre la scrittura sull’obelisco Papa Alessandro VII Chigi contattò il gesuita Athanasius Kircher, presso il Collegio Romano. Il più eminente “pseudo” decifratore dei geroglifici del XVII secolo tradusse quanto segue:” La protezione di Osiride contro la violenza del nemico Tifone deve essere attirata secondo i riti appropriati e le cerimonie con sacrifici e mediante l’appello al genio tutelare del triplice mondo per assicurare il godimento della prosperità tradizionalmente concessa dal Nilo contro la violenza del nemico Tifone” “Sei sapiente elefante, Minerva custodite bene insieme questa piazza”. Solo nel 1822, infatti,
J
ean François Champollion riuscirà a decodificare la scrittura egizia grazie alle tre differenti grafie riportate sulla Stele di Rosetta: il geroglifico, il demotico e il greco antico. La base dell’opera cita una dedica voluta da papa Alessandro VII: “Chiunque qui veda i segni della Sapienza d’Egitto scolpiti sull’obelisco, sorretto dall’elefante, la più forte delle bestie, intenda questo come prova che è necessaria una mente robusta per sostenere una solida sapienza”. L’obelisco è posizionato sulla groppa di un elefante marmoreo, scolpito da Ercole Ferrata su disegno di Gian Lorenzo Bernini nel 1667. Il modello dell’elefantino fu offerto da un elefantino portato in omaggio all’Urbe da Cristina di Svezia convertitasi al Cattolicesimo. Ma segue anche una iconografia mutuata dall’Hypnerotomachia Poliphili (Combattimento amoroso di Polifilo in sogno) vero e proprio best seller dell’epoca, romanzo allegorico del frate Francesco Colonna e stampato dal veneziano Aldo Manuzio nel 1499. Vero e proprio viaggio dell’anima, intrapreso in lotta con Amore per raggiungere la vera Sapienza, è un pellegrinaggio onirico che richiama alla mente le Metamorfosi di Apuleio. Il modello del Bernini, che già aveva espresso il suo virtuosismo di una struttura cava portante, quali nella Fontana del Tritone e nella Fontana dei Quattro Fiumi, fu scelto al posto di quello proposto dai Domenicani. Per questo motivo parrebbe il cosiddetto Pulcino essere posto nel dare le terga al convento dei frati ostentando irriverenza con la proboscide e la coda spostata. Il gemello dell’obelisco è a Urbino. Piè di Marmo

Piede di Marmo
A Via di Piè di Marmo, a pochi passi da Piazza della Minerva, capita di imbattersi in un piede di marmo! Sorprende trovarlo in un angoletto tra i vicoli di Campo Marzio, l’ipotesi è che appartenesse ad una colossale statua di Iside, probabilmente al busto oggi posizionato presso la Chiesa di San Marco. Qui ci troviamo nel cortile rettangolare del tempio di Iside e Serapide dove avremmo trovato, nel I secolo d.C., l’obelisco agonale, proprio di fronte alla grande esedra decorata con un bacino che ricordava le acque del Nilo per i riti dei sacerdoti. La chiesa di Santo Stefano del Cacco fu costruita proprio sopra il santuario dedicato a Serapide. Quando venne rinvenuta una statua con le sembianze di un macaco, o babbuino, per corruzione linguistica il macaco diventò cacco. Da qui il nome della chiesa. La statua rappresentava il Dio Thot, la divinità celeste delle lettere e della scrittura. Fece parte della collezione Ludovisi. Oggi si trova ai Musei Capitolini. Il piede si trova in questo angusto angoletto perché spostato dalla via centrale per permettere il passaggio del corteo funebre di re Vittorio Emanuele II al Pantheon, avvenuto nel 1878. Qui esisteva all’epoca la bottega di un calzolaio e si dice che fu proprio lui a spostare il piede per farsi pubblicità. Rodolfo Lanciani capo della Commissione Archeologica Comunale che organizzò gli scavi nell’area alla fine dell’800, ci ha lasciato una preziosa testimonianza degli innumerevoli reperti di inestimabile valore. Dall’Iseo Campense provengono opere custodite nei musei più importanti nel mondo, basti menzionare la statua del Tevere al Louvre o la statua del Nilo ai Musei Vaticani, la statua di Oceano oggi a Napoli e ancora altari isiaci, sfingi, coccodrilli in granito rosso, grigio, verde, rosa, due colonne istoriate con bassorilievi del tempio vero e proprio, sette capitelli, fusti con rilievi egittizzanti, la Mensa Isiaca, una tavola d’altare con finti geroglifici interpretata fantasiosamente dal Kircher e passata di mano in mano da Pietro Bembo ai Gonzaga e poi ai Savoia nel ‘600 per essere esposta, infine, al Museo Egizio di Torino.
I
l Lanciani ci racconta che la sfinge in basalto nera del faraone Amasis, usurpatore del trono di Apries (il faraone dell’obelisco della Minerva) fu ritrovata dietro all’abside della Basilica di Santa Maria sopra Minerva ed è un capolavoro di scuola saitica che subì la damnatio memoria da parte di Cambise quando occupò l’Egitto. Il cartiglio del re, infatti, è scalpellato di proposito, così come il naso e l’ureus, simbolo di regalità. La spiegazione è data da Erodoto: Amasis era già sepolto quando arrivò Cambise sulla terra bagnata dal Nilo, fece disseppellire il cadavere, lo profanò e lo bruciò. Seicento anni dopo forse un mercante romano, per far dono al tempio, la portò qui senza conoscerne la storia. Insomma, in poco meno di 100 metri, abbiamo una sinossi di storia egizia tra il 596 e il 526 a.C. 
Ma non finisce qui: il Sig.Tranquilli nel 1858 scoprì nella sua cantina allagata in via di Sant’Ignazio reperti preziosi, tra cui una sfinge di granito verde con la testa della regina Hashepsut (oggi nella Collezione Baracco) e Iside che allatta Horus in forma di vacca in granito rosso; nel 1859 il Sig.Silvestrelli, nella casa accanto, trovò cinque capitelli oggi al Museo Etrusco Gregoriano. Poco più in là, verso piazza del Collegio Romano, all’angolo di un edificio si nota un pilastro di marmo. Ebbene, è ciò che rimane del famoso Arco di Iside, identificato da Antonio da Sangallo e nel Medioevo denominato “Arco di Camigliano”, localizzato minuziosamente da Raffaello all’epoca di Leone X de’ Medici e rinvenuto nel 1969 in opera quadrata sotto terra. L’arco monumentale è rappresentato nei rilievi della tomba degli Haterii, risalente al II sec. d.C. e scoperta nel 1848 sulla via Labicana. Ma come era il Tempio di Iside e di Serapide? L’Iseo Campense era il più antico ed esteso santuario egizio presente a Roma, il più grande in tutto il bacino del Mediterraneo dopo il Serapeo di Alessandria d’Egitto. Grazie ad una moneta dell’età di Vespasiano del 71 d.C. sappiamo che il santuario dedicato a Iside era tetrastilo con raffigurata Iside a cavallo della stella Sirio scolpita sul frontone e statue su basamenti sulla scalinata. La statua era ritratta nell’atto di libare con nella mano dx una coppa. Anche la Forma Urbis Severiana del III secolo d.C. riporta tre blocchi riferibili al tempio. Cassio Dione in Storia Romana riporta la costruzione del santuario nel 43 a.C. voluta dal Triumvirato di Ottaviano, Marco Antonio e Lepido ma non abbiamo prova che fu effettivamente costruito, forse si trattò di un altare per ottenere il consenso del popolo dopo la morte di Cesare. Ma il culto subì persecuzioni da parte di Augusto e di Tiberio, tanto che quest’ultimo lo distrusse gettando i simulacri nel Tevere e crocifiggendo i sacerdoti. Nella sua opera Antichità romane Giuseppe Flavio, storico giudeo romano, nonché consigliere di Vespasiano e Tito, ci riporta lo scandalo del cavaliere Decio Mundo e della matrona romana Paolina a cui seguì la distruzione punitiva voluta da Tiberio nel 19 d.C. Come punto di riferimento vero e proprio teniamo conto della ricostruzione effettuata al tempo di Caligola, tra il 37 e il 41 d.C. e la ricostruzione di Domiziano dopo l’incendio dell’80 d.C. Fu restaurato più volte e decorato con statue preziose. L’edificio in stile ellenistico – romano,
a
veva una lunghezza di 220 metri per una larghezza di 70 metri, altri studiosi riportano una lunghezza di 240 metri per una larghezza di 60 metri, comunque una superficie che occupava un’area di circa 15000mq. L’ingresso principale si apriva all’altezza di via del Seminario con una sorta di viale monumentale, contrassegnato (come evidenziato nella pianta severiana) da una serie di punti troppo distanti per essere colonne. Quindi si presuppone che siano obelischi ritrovati in zona posti due a due e sfingi in sequenza. C’erano le cappelle dedicate agli dèi, come thot, anubis ecc. lungo il vialone d’entrata. Al centro la cella di Iside. La mappa di Kircher ricostruisce tale struttura. All’inizio del IV secolo d.C. conteneva i propylaia ossia le torri piramidali tipici dei templi egizi con un ingresso ad ogni estremità del dromos o corridoio sacro. Il cortile del santuario si apriva con due lati brevi con due archi: ad ovest il cosiddetto “Arco Quadrifronte”, alto circa metri 21 e largo 11, che metteva in comunicazione il santuario con gli adiacenti “Saepta Iulia” attraverso il “Portico di Meleagro” (che correva esattamente lungo l’attuale via del Gesù), mentre ad est si apriva l’Arco di Iside. Seguiva un grande cortile rettangolare, (corrispondente all’attuale via del Pie’ di Marmo), al centro del quale era situato un altro obelisco, di dimensioni maggiori degli altri e quindi isolato, corrispondente a quello oggi situato a piazza Navona. Forse qui vi era anche la Pigna vaticana Superato il cortile si apriva un’esedra semicircolare, scoperta e porticata: qui, al centro del lato curvo, si apriva il tempio vero e proprio, oggi corrispondente esattamente alla collocazione della chiesa di S. Stefano del Cacco. Qui si trovava la statua di Serapide.

Pilastro Arco di Iside

Rilievo degli Hateri con Arco di Iside


La Gatta

La Gatta sul cornicione di Palazzo Grazioli
Non può sfuggirci la gatta murata sul primo cornicione di Palazzo Grazioli e a cui si deve il nome della strada. La tradizione vuole che la statuetta sia stata posta qui in ricordo di una gatta che con il suo miagolio salvò un bambino da una caduta certa. Qualcuno crede che seguendo lo sguardo della gatta trovi il luogo in cui è nascosto un tesoro. Mai successo. Si pensa che provenga dal tempio ma dalle sembianze non presenta caratteristiche egizie vere e proprie. Sicuramente il culto di BASTET nel delta del Nilo era famoso al punto che son state ritrovate tombe con gatti mummificati. Bastet in origine simboleggiava il calore del Sole ed era venerata per la sua agilità, potenza e forza. Bastet era l’occhio di Ra, figlia di Ra divinità anche lunare, capace di annientare i nemici dell’Egitto.

Madama Lucrezia alias Iside Sothis

Madama Lucrezia

Iside Aset

Serapide

Osiride
In piazza San Marco sul lato ovest dell’entrata della chiesa, in un angoletto si trova una statua che sembra abbandonata. E’una statua di epoca romana che fa parte della cosiddetta “congrega degli arguti”, il gruppo delle statue parlanti di Roma, così chiamate in quanto su di esse venivano appesi cartelli con scritte anonime pungenti e satiriche contro i potenti del momento. Da qui nasce il modo di dire le pasquinate. Tra le statue ricordiamo Marforio, Pasquino, il Facchino, l’abate Luigi e il Babuino. Il busto, alto tre metri, un tempo era posto davanti all’entrata della chiesa dell’antica piazza, in pratica sull’angolo orientato verso l’attuale Piazza Venezia. L’ipotesi più accreditata è che rappresenti la dèa Iside o una sua sacerdotessa. Si presume che il piede di marmo appartenesse a questa statua. Appare evidente il nodo della veste, il tiet, simbolo di Iside sul petto: il tiet, simile all’ankh, “la chiave della vita”, è un simbolo magico di convergenza tra forze umane e divine. A partire dal Nuovo Regno, l’amuleto si trasforma in nodo nel vestiario raggiungendo la massima diffusione nel periodo tolemaico-romano. L’amuleto assicurava protezione in vita e nel corso del viaggio verso l’aldilà, connesso al culto di Osiride e chiamato in origine anche Nodo di Seth o Nodo della vita. Il simbolo veniva usato spesso nella decorazione di tombe, nei bassorilievi e nei corredi funerari in unione al pilastro djed, simbolo di stabilità connesso ad Osiride. Citato nel Libro dei morti – cap. 156 – l’amuleto doveva essere portato al collo per ottenere la protezione di Iside della quale rappresentava la magia ed il sangue. Era perciò realizzato in pietra rossa come il diaspro ma anche in oro che restava sempre il metallo più ambito. Perché il nome di Madama Lucrezia allora? Ebbene, il busto è legato alla vicenda amorosa tra Lucrezia D’Alagno, di nobile lignaggio, amante di Alfonso V d’Aragona, re di Napoli che nel 1448 si innamorò di lei appena diciottenne. Nel 1457 Lucrezia tentò di avere da Callisto III, zio di un cognato, l’annullamento del matrimonio del re con la regina Maria di Trastàmara che viveva in Spagna. Il tentativo fallì. I suoi sogni si infransero definitivamente l’anno dopo, quando Alfonso morì. Si trasferì a Roma nei pressi della piazza e della statua; quando morì nel 1479 Lucrezia fu sepolta a Santa Maria sopra Minerva, dove non resta più nulla. Il nome della madama rimase nel sentimento popolare romano. Lucrezia viene ricordata da Benedetto Croce in alcuni suoi saggi. Gioacchino Belli ci racconta che la statua presiedeva il cosiddetto “ballo dei poverelli o dei guitti”, una sorta di carnevale dei poveri che si teneva il primo maggio. In quell’occasione la statua veniva decorata con corolle di agli e cipolle e tinta di rosso nel viso, tanto che il famoso scienziato gesuita Athanasius Kircher scrisse di lei: «Io, ridotta a metà, col volto tinto di rosso son chiamata Lucrezia, molto mi compiaccio che mi si dia così un po’ di belletto in modo da sembrare giovine sposa».
L'articolo
Gli obelischi (e non solo) dell’Iseo Campense a Roma
proviene da Rome With Suzy
.