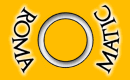Martedì 9 Febbraio 2021 12:02
Del mistero e della malinconia dei piccoli musei
“… l’opera d’arte dovrebbe partire da un’idea … l’artista deve sapere che cosa vuole fare … Magari un ritratto o
… Continua...
leggi la notizia su Cultura e Spettacoli - ABITARE A ROMA
Può capitare, in una bella e tiepida mattinata di un febbraio quasi primaverile – con le prime margherite che punteggiano di bianco il verde intenso dei prati, ombreggiati qui e là dall’improvvisa trionfale esplosione giallo-oro che ha ricoperto in questi giorni i maestosi alberi di mimosa – di voler fare una passeggiata in un luogo ben conosciuto e super frequentato della nostra città, ad esempio un parco pubblico come Villa Borghese, che chiunque abiti a Roma crede (illusoriamente) di conoscere in tutte le sue attrattive e meraviglie.
Può anche accadere di voler profittare di un evento del tutto casuale (ma legato agli sviluppi della pandemia da Covid 19) quale la retrocessione della nostra regione da “zona arancione” a “zona gialla”, e della conseguente riapertura dei musei, al fine di dedicare parte della passeggiata mattutina alla visita, finora sempre rinviata, di due quasi minuscoli musei che costituiscono due piccoli scrigni della bellezza disseminata a piene mani nella nostra città e, in una misura non trascurabile, in un’area come Villa Borghese; un parco che, fin dalla sua creazione, il suo fondatore (il cardinale Scipione Borghese, nel XVII secolo), e i suoi intelligenti e munifici discendenti e prosecutori (il principe Marcantonio Borghese e il suo figliolo Camillo, rispettivamente nel XVIII e nel XIX secoli), hanno voluto offrire allo svago e al godimento artistico del popolo.
I due piccoli musei in questione sono: il Museo Bilotti (situato nell’ex Aranciera della Villa, all’interno dell’area del Giardino del Lago, in posizione decentrata rispetto al laghetto e al Tempio di Esculapio), al tempo di Marcantonio Borghese denominato “Casino dei Giochi d’Acqua” e, dopo le rovine provocate dai cannoneggiamenti che posero fine alla Repubblica Romana del 1849, adibito a deposito di agrumi (da cui il nome Aranciera); edificio restaurato negli anni dell’amministrazione di Walter Veltroni e destinato all’esposizione della piccola ma preziosa Collezione di Carlo Bilotti (industriale italo-americano, mecenate e collezionista di notevoli opere d’arte), da lui donata al Comune di Roma.
L’altro è il Museo (o, per meglio dire, la Casa Museo) di Pietro Canonica, nell’edificio denominato “Fortezzuola” (così a causa del suo aspetto) ma, in origine, chiamato il “Gallinaro” perché vi si allevavano struzzi, pavoni e anatre; un edificio che si trova, in posizione leggermente sopraelevata, dirimpetto a Piazza di Siena. Il Museo Canonica è la casa con giardino dove lo scultore visse e operò dal 1926 al 1959, anno della sua morte. Dal 1987 l’edificio, dove già era stata raccolta una notevole collezione di sculture (soprattutto calchi dei monumenti funerari e celebrativi – che furono la caratteristica peculiare dell’arte dello scultore e musicista piemontese, nonché senatore a vita dal 1950 – eseguiti su commissione e destinati ad adornare piazze, palazzi e sepolcri di molte personalità, sparsi in Europa e nel mondo.

Nella collezione Bilotti (appena 22 opere) spiccano le numerose opere di Giorgio De Chirico, risalenti per lo più agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e che rappresentano tarde versioni di capolavori eseguiti a cavallo della prima guerra mondiale, il periodo più prolifico del nostro pictor optimus, quello della pittura metafisica, quello delle piazze d’Italia, dei manichini e archeologi, dei cavalli in riva al mare, di Ettore e Andromaca, delle fabbriche e dei treni e, soprattutto, del meraviglioso Mistero e malinconia di una strada. Fanciulla con cerchio. Quest’ultimo, sebbene sia una tarda versione (anni Sessanta) del capolavoro del 1914, e contenente piccole varianti rispetto all’originale, è una delle opere più importanti e “filosofiche” del maestro. Lo spazio è occupato quasi interamente da due edifici porticati tra loro contrapposti e diversamente colorati; quello a destra dell’osservatore è parzialmente nascosto da una sorta di cassone privo di ruote da cui fuoriescono dei bagagli, non sappiamo se provenienti da un trasloco o da uno sfratto; al centro, in diagonale rispetto ai due edifici, si apre una strada che punta dritta verso un orizzonte appena accennato; in basso a sinistra e all’inizio della strada si nota una figurina, anch’essa sommariamente descritta, di bambina che, correndo, allunga una mano tenendo un cerchio in movimento; più lontano, lungo la stessa strada e seminascoste dall’edificio sulla destra, si allungano due ombre di dimensioni diverse; in alto un cielo blu che tende al nero.
Non vi è una storia nel quadro: la strada, gli edifici, il cielo, suggeriscono immobilità e solitudine; a queste si oppone vanamente e inconsapevolmente la bambina che corre all’inizio della strada, non accorgendosi delle ombre inquietanti e minacciose che sembra vogliano, di lì a poco, impedirle di proseguire. Lo spazio, come in tutte le opere metafisiche di De Chirico, è ridotto alle più elementari ed immutabili forme geometriche (le linee rette e curve, il cerchio, i volumi architettonici che dalla loro combinazione e mescolanza derivano) che sono alla base della realtà fenomenica. Il tempo, rappresentato simbolicamente dal movimento della bambina, è sopraffatto dall’eterna immobilità degli edifici e dall’oscurità prevalente sulla superficie del quadro. Un tempo, oltretutto, non lineare, non progressivo, bensì circolare, come sembra volerci suggerire quel cerchio che non è che la metafora dell’eterno ritorno dell’identico. E così, in questo capolavoro, De Chirico si limita, utilizzando pochi ed essenziali elementi e una tavolozza di colori tra loro nettamente distinti, ad esprimere la sua filosofia della vita, una filosofia che trova i suoi principali riferimenti in Schopenhauer e in Nietzsche. Del primo accoglie l’opinione di un mondo fenomenico e storico caotico e privo di senso, un mondo nel quale è possibile orientarsi – senza però alcuna prospettiva di progresso – con l’aiuto delle forme a priori dello spazio, del tempo e della causalità (o principio di ragion sufficiente); del secondo l’ossimorica definizione della storia come “eterno ritorno dell’identico”. Non c’è da stupirsi, di fronte a questa desolante concezione, che le parole mistero e malinconia (aggiungerei però anche straniamento) siano le più adatte a rendere conto delle sensazioni suscitate dalla pittura metafisica.